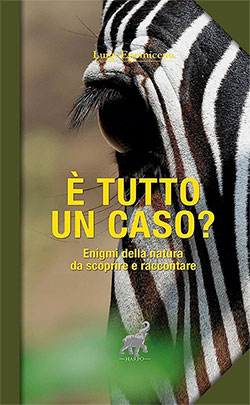L’appuntamento imperdibile di settembre, in Abruzzo, è la Corsa degli Zingari di Pacentro (AQ), uno dei borghi più belli d’Italia. Il paesino si allunga su un contrafforte del Morrone nell’area Peligna del Parco Nazionale della Majella e si riconosce facilmente dal profilo disegnato dalle torri del Castello Caldora. I vicoli si inerpicano come un serpente di pietra, tra vie, archi, scale e camminamenti. Non ci sono macchine.

Il giorno della festa Matteo Salvini può lasciare le ruspe in garage. Non si troverà davanti a una massa di uomini e donne di etnia rom, ma a un gruppo di ragazzi più o meno giovani (rigorosamente del luogo) che si arrampicano e corrono scalzi lungo il Colle Ardingo, dal lato opposto del paese: gli zingari, appunto. Una sorta di palio dei tempi poveri, in cui si mescolano sacro e profano; un rituale particolare in onore della festa della Madonna di Loreto. Viene organizzato da Giuseppe De Chellis, capo dell’omonima associazione, assieme alla Confraternita della Madonna di Loreto.
Scalzi, zingari in dialetto arcaico pacentrano. La parola zingaro non sta per nomade. Era sinonimo di morto di fame, persona povera in canna che non possedeva neanche i soldi per acquistare un paio di scarpe. Fino a qualche anno fa i partecipanti erano contadini, operai o pastori del luogo. Alcuni tornano tuttora dall’estero per partecipare. L’occasione è troppo ghiotta per non piazzarci la traccia “Like a Prayer” di Veronica Ciccone, Madonna, che è nata in questo paese. (“Life is a mystery, everyone must stand alone I hear you call my name / And it feels like home…”). Nel settembre del 1987 la pop star incontrò a Torino i parenti, ospiti del suo concerto. In quell’occasione Pacentro finì sui giornali e sulle televisioni di mezzo mondo e nello stesso 1987 la Corsa degli Zingari venne regolamentata. Si stabilì che dovesse tenersi nel pomeriggio della prima domenica di settembre.

La festa comincia al mattino con la Messa in onore della Madonna cui segue la processione; nel pomeriggio la corsa. Il numero dei partecipanti è limitato, una trentina circa, tutti rigorosamente pacentrani. Qualche ora prima, ai più piccoli (7-12 anni) è riservata la Corsa degli Zingarelli. Anche loro, a piedi scalzi, percorrono le vie principali del paese a partire dal suono della campanella della Chiesa della Madonna di Loreto.
Prima dell’inizio della gara, i partecipanti si radunano presso un roccione che sporge di fronte al paese, Pietra Spaccata. Ai primi rintocchi della campana, inizia la corsa frenetica per un sentiero pieno di pietre e rovi. Oltrepassano il fiume Vella e risalgono, stremati, in direzione del paese verso la chiesa della Madonna di Loreto. La porta della chiesa è aperta, l’altare è il traguardo. Quando arriva l'ultimo concorrente, la porta della chiesa si chiude. Con i piedi a pezzi e sanguinanti, i partecipanti ricevono le prime cure da medici e infermieri. Il vincitore riceve in premio un simbolico palio, che consiste in un taglio di stoffa che un tempo si utilizzava per il vestito buono, una coppa e una modesta somma di denaro. Viene portato in trionfo per il paese tra due ali di folla e accompagnato dalla banda musicale fino a casa, dove i genitori offrono vino in segno di augurio e prosperità.

Vengono concessi premi minori, di carattere sportivo, anche all’ultimo classificato, al più giovane e a chi si fa più male. Ma non è questo l’obiettivo. Basta notare il carico emotivo prima, dopo e durante la competizione. C’è chi si prepara alla corsa per mesi. Padri, figli e nipoti si tramandano dritte sugli allenamenti, per competere sullo stesso percorso. Pochi minuti brutali; una prova di forza e di resistenza.
Tanto sacrificio e violenza, a che pro? La storia è antica, un’usanza remota che ha preso nuove forme. Il culto della Madonna Lauretana precede di molto la costruzione della chiesa (‘700). I pacentrani si recavano a piedi a Loreto, nelle Marche, in un pellegrinaggio che durava quasi una settimana. Un cammino faticoso e pieno di insidie. La teoria religiosa associa il rito della corsa al volo della Madonna di Loreto, dalla casa di Nazareth alle Marche. La si vide posarsi sul Colle Ardingo per poi raggiungere Pacentro, a piedi nudi, decretando il luogo di culto. La versione pagana risulta ovviamente più realistica e la riconduce a un atto di rivalsa sociale. Nel Medioevo, i poveracci che correvano nudi per raggiungere il traguardo ambivano alla vittoria perché in premio vi era un posto da paggio alla corte del principe. Secondo altre ricostruzioni, un ruolo da cadetto nell'esercito del condottiero Giacomo Caldora, il feudatario medievale di Pacentro.
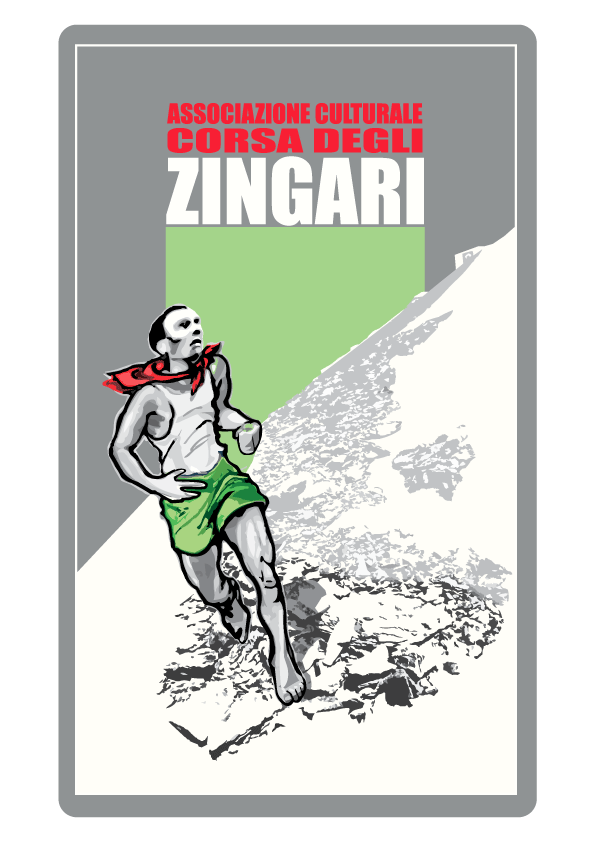
La corsa riappare in altre rappresentazioni sacre pervenute sino ai giorni nostri; Madonne che scappano in piazza a Sulmona e in centri meno noti, come Corropoli (TE) e Introdacqua (AQ). Come altri riti della cultura contadina, questo cade in un momento importante del ciclo produttivo; a settembre si avvicina la vendemmia e si conclude la stagione agricola. Così come una volta le scadenze rappresentavano la festa del ritorno dal lavoro (giugno) e della partenza (settembre) del pastore, del carbonaio o del calcarolo. Forse la funzione attuale della corsa, in un paese svuotato dall’emigrazione, è la riappropriazione delle radici, del valore antropologico e simbolico. Oggi, per gli Zingari, partecipare e vincere la Corsa alimenta il senso di appartenenza.
Lo scorso 17 giugno, a Pescara, è stato presentato in anteprima mondiale, durante i Premi Internazionali Flaiano, il film ”Carne et Ossa” prima dell'uscita al cinema e in streaming il prossimo autunno. Un documentario diretto da Roberto Zazzarae prodotto da IFA Scuola di Cinema per il progetto IFA Glocal Film in associazione con Sulmonacinema, che racconta un'usanza abruzzese ancestrale.
 Gabriella Di Lellio
Gabriella Di Lellio