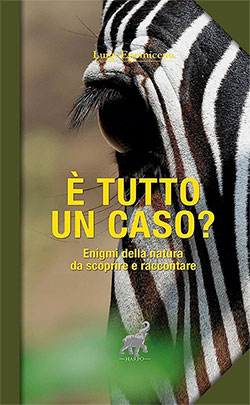L’enciclopedia bresciana di Mons. Antonio Foppani indica che con il nome di leghe bianche vennero chiamate, “in contrapposto alle Leghe rosse, socialiste, le leghe sindacali, specie contadine, aderenti alle Unioni cattoliche del lavoro fondate nel 1900”. Lo sviluppo di tali unioni sindacali, in particolare nel Mugello, si lega al repentino sorgere ed al forte radicamento del Partito popolare alle elezioni dal 1919 al 1921. A San Piero a Sieve, dove fin dall’Unità d’Italia i vari sindaci avevano avuto solo tre cognomi, tutti aristocratici liberali: Cambray-Digny, Corsini e Gerini, l’insediamento nel 1920 della Giunta del popolare Ubaldo Rossi interrompe un dominio che durava dai tempi del Granducato. Rilevante, in Mugello, è l’opera del giovane segretario dell’Unione mugellana del lavoro, Ottorino Orlandini, figlio di un mezzadro bianco di Mosciano e dei dirigenti mugellani della Federazione mezzadri e piccoli affittuari tra cui Ismaello Ismaelli, contadino a San Giovanni a Panicaglia, detto Nello o Nello di’ Lemmi.

Quest’ultimo è il capo delle Leghe Bianche del Mugello. È lui che organizza i contadini dopo la grande guerra, è un nocentino, ovvero uno dell’Istituto degli Innocenti, adottato, alla nascita nel 1881, dalla famiglia Lemmi della Parrocchia di S. Giovanni Maggiore Il patto colonico mugellano, stipulato con la Federazione mezzadri nella seconda metà del 1919 dopo forti proteste e scioperi molto partecipati dei contadini, trova l’opposizione dei proprietari. È soprattutto nel mandamento di Scarperia che si registrano le più forti resistenze di latifondisti che portano alcuni fra i cognomi più blasonati della regione: i Gerini di villa Le Maschere, i Dapples, i Cambray-Digny di villa Schifanoia, i principi Borghese della villa medicea di Cafaggiolo. L’Agraria fa di tutto affinché il nuovo concordato concluso il 29 ottobre non sia ratificato. Parte dunque una seconda fase delle lotte contadine e l’agitazione, per la prima volta in Toscana, non si attua con la forma dell’astensione dal lavoro, ma con l’inedita modalità dell’assunzione in gestione diretta delle aziende da parte dei mezzadri, una pratica paragonabile all’occupazione delle fabbriche.
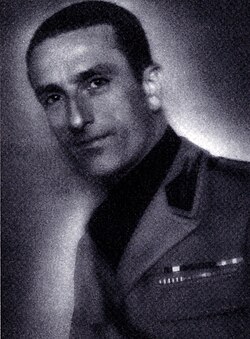
Inizia tutto i primi di dicembre: i contadini collocano sui pagliai, sui comignoli più alti delle fattorie, un bastone con uno straccio bianco (una vecchia camicia, un pezzo di lenzuolo, un asciugamano). È il segnale della lotta, e la bandiera bianca sventola così su tutte le case del Mugello, perfino su tutti i carri di buoi e su tutte le criniere dei cavalli: “la bandiera bianca era diventata il lasciapassare in tutta la zona” (Ottorino Orlandini, opera memorialistica, senza titolo, conservata in copia dattiloscritta in ISRT, Istituto storico della resistenza in Toscana, capitolo II, p. 5). I coloni dimostrano che le aziende e il lavoro dei campi possono benissimo funzionare e proseguire senza la presenza e la conduzione del proprietario. Il nuovo patto colonico mugellano è firmato da ben 84 proprietari, nei confronti dei quali è subito cessata ogni misura di rigore. L’agitazione prosegue senza incidenti (“Il Messaggero del Mugello” 12 dicembre 1920). Ma tale affermazione è tragicamente smentita di lì a pochi giorni. Gli agrari, in preda al panico, ricorrono alle squadre fasciste come a strumento di repressione.
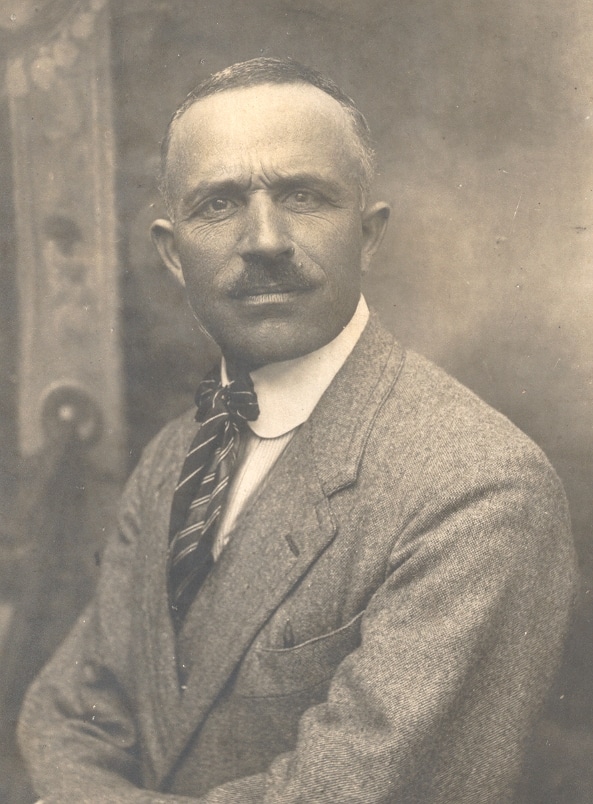
Si è scritto che la nobiltà fiorentina, al colmo dell’esasperazione, “si decise a partire alla riscossa e offri un sostanzioso finanziamento al Fascio di Firenze” (scrive O. Orlandini). Tra i fascisti più violenti fin dagli inizi si distingue lo “studente” Amerigo Dumini. Nel dicembre cominciano le spedizioni delle squadracce nelle campagne. La situazione più grave si verifica a San Piero a Sieve poiché nel Mugello occidentale si concentrano i proprietari più chiusi ed intransigenti. Fra di essi vi è anche la contessa Marianna Cambray-Digny, proprietaria della tenuta di Schifanoia, fortemente legata agli ambienti fascisti. L’amministratore della contessa è infatti il dottor Antonino Giunta, nientemeno che il padre di Francesco Giunta, noto squadrista, autore della tragica spedizione che il 13 luglio del 1920 mette a fuoco il Narodni Dom presso l’Hotel Balkan di Trieste. Alla fine di novembre tutte le fattorie e i poderi di Cambray-Digny sono occupati e su di essi sventola la bandiera bianca. Il 6 novembre 1920 si verifica un primo assalto dell’abitazione privata della contessa Cambray-Digny, la villa Schifanoia. A guidare l’assalto è Ottorino Orlandini e l’ordine viene dalla Federazione bianca e a portarlo da Borgo San Lorenzo a San Piero a Sieve è, in bicicletta, un ragazzino quindicenne, Maurizio Vigiani.

Il cancello della villa è divelto da decine di mezzadri che agitano bandiere bianche ed uno dei figli di Giunta (probabilmente non Francesco, ma Giovanni), estrae una pistola. Ottorino Orlandini riesce a essere ricevuto dalla contessa, ottenendone generiche promesse. Ma l’indomani la contessa fa pubblicare su 'La Nazione' una diffida contro i propri mezzadri, invitandoli a desistere dall’occupazione e dalla gestione diretta dei propri poderi, ammainando le bandiere bianche. Il primo dicembre del 1920 il parco della villa viene nuovamente occupato. Secondo Orlandini è la contessa in persona, stavolta, a puntargli contro una carabina. Accorrono i carabinieri e sgombrano il parco. Pochi giorni dopo, il 10 dicembre, il dramma. L’accaduto è così descritto da Roberto Cantagalli nel suo libro 'Storia del Fascismo fiorentino': “Sull’ora del mezzogiorno, un camion di squadristi arriva cantando alla villa di Schifanoia. Uno dei capi del fascismo fiorentino e poi italiano, perché per un certo periodo fu anche segretario generale del PNF, il nazionalista, capitano e avvocato Francesco Giunta, ex organizzatore delle prime squadre d’azione messe su dall’Alleanza di difesa cittadina, era nativo di San Piero a Sieve. Giunta era stato negli anni giovanili uomo di particolarissima fiducia della contessa Cambray Digny. Considerato questo, non sembrerà strano che i fratelli di Francesco e i loro camerati di Firenze fossero di casa alla vila di Schifanoia e che quel giorno fossero invitati, per telefono, a pranzo nell’accogliente sala della ospitalissima loro anfitriona. Qui giunti, in 12, sostarono fino alle tre in lauto banchetto. Dopo pranzo presero l’impegno di fare 'un favore' alla contessa, e cioè di fare 'un giretto' per le fattorie e per le aie delle varie case coloniche a consigliare amichevolmente, a mettere una 'buona parola' coi contadini per convincerli a recedere dallo sciopero, ritirare dalla cima dei pagliai quei loro cenci bianchi e tornare al lavoro”.

Giunti a Fagna “sorpresero in un’aia un vecchio, due giovani e delle donne. Piombarono loro addosso ingiungendo di togliere le bandiere e poiché quelli tergiversavano spararono al solito vari colpi in aria. I contadini si chiusero in casa e sprangarono l’uscio: i fascisti imprecando e bestemmiando sfogarono la loro rabbia scaricando le rivoltelle contro la porta chiusa. Una pallottola raggiunse il Giovanni Sitrialli, vecchio contadino di 72 anni, che morì sul colpo. I dodici non se ne accorsero nemmeno e mezzi ubriachi ritornarono a Firenze. I capi della spedizione erano: Luigi Zamboni, Bruno Frullini, Manfredo Chiostri, Italo Capanni”. Ai funerali del colono ci sono 2.000 contadini, con Ismaello Ismaelli fra loro, armati di bastone e pronti a difendersi. Si forma un corteo da Fagna fino a Scarperia, composto da circa 5000 persone.
Per tutto il mese di dicembre 1920, malgrado la minaccia fascista, l’agitazione bianca prosegue con vigore in tutto il Mugello e tutte le principali fattorie sono ormai occupate dai coloni bianchi. Contro i contadini la proprietà preferisce adire le vie legali. A dare l’esempio è, ancora una volta, la contessa Cambray-Digny, la quale fa diffidare non solo i contadini occupanti ma anche gli eventuali acquirenti del bestiame e altro. La seguono molti altri proprietari terrieri. Le aggressioni fasciste riprendono con particolare accanimento. Il movimento delle leghe bianche non si riprende più e, minato anche da spaccature interne, finisce per essere definitivamente sconfitto lasciando sul campo meravigliose illusioni e il triste primato del primo morto in Italia per mano fascista, l’anziano colono Giovanni Sitrialli, detto Giannara.

Ma che fine hanno fatto i protagonisti di questa storia? La squadra fascista è capitanata da Italo Capanni e Manfredo Chiostri (vi sono poi Bruno Frullini e Luigi Zamboni nonché Pier Antonio e Bruno Rosai, Massimo Escard, Carlo Nobili, Baldi Delle Rose, Mario Nerbini, Pasquale Lazzeri, Angiolo Massa e Corrado Mieli). Italo Capanni si macchia anche dell’assassinio a Firenze di Spartaco Lavagnini, ma lo premiano con un posto in Parlamento. Anche Manfredo Chiostri è eletto al parlamento nelle file del PNF. Francesco Giunta, “fascista e squadrista convinto” (parole sue), segretario del partito e governatore della Dalmazia. Processato due volte per il delitto Matteotti è sempre assolto. È accusato di essere un criminale di guerra dalla Repubblica di Jugoslavia. Non viene mai estradato né processato. Amerigo Dumini è responsabile dell’assassinio di Matteotti e di innumerevoli altre nefandezze. In mano agli alleati sfugge miracolosamente alla fucilazione. Processato in Italia, condannato a 30 anni, nel 1956 fruisce della liberazione condizionale e finisce per morire alcuni anni dopo cadendo in casa mentre inseguiva non si sa se il suo cane o il suo gatto (la storiografia ne discute da decenni).

Ottorino Orlandini, antifascista, combatte con Carlo Rosselli in Spagna, si iscrive al Pd’A e comanda le sue formazioni militari in Toscana. Arrestato dalla banda fascista di Mario Carità, è massacrato di botte. Evade e combatte nella battaglia di Firenze. Dopo la guerra si iscrive alla Democrazia Cristiana e scrive un memoriale custodito presso l’ISRT e pubblicato nel 2022 da Sarnus. Maurizio Vigiani, il ragazzino che portò l’ordine di attaccare la tenuta Cambray-Digny, diventa senatore della Democrazia Cristina nel 1948. Ismaello Ismaelli, V elementare (forse), odia il fascismo e si dà alla macchia. Gli dà la caccia Amerigo Dumini, che non riesce ad acciuffarlo. Partecipa alla Resistenza nella brigata Carlo Rosselli Giustizia e Libertà e nel grande sciopero generale del marzo 1944 è presente per la categoria dei contadini. Dopo la fine della guerra continua a rappresentare i coloni. Gli conferiscono il cavalierato nel 1953. Muore nel 1976 a 95 anni attorniato dalla famiglia e dall’immenso amore del Mugello. Marianna Cambray-Digny: di lei, figlia del senatore del regno Guglielmo, sappiamo che ha lasciato un ritratto di Frate Pietro Doni, guardiano di Bosco ai Frati, da essa realizzato prima dei fatti narrati in questa storia. Pare che la contessa volesse un gran bene a Giulia, ragazza che, a 21 anni, per amore si impiccò a una trave all’interno di villa Schifanoia e che per essa fece realizzare il più bello dei loculi.
Villa Schifanoia è proprietà di privati. Abbiamo sue notizie da tripadvisor: “Comprende un'azienda agricola biologica, una riserva privata di caccia al tartufo, un certo numero di ville Colonica in affitto e un convento di 1000 anni. Lavoriamo attivamente con un team di tartufai locali e i loro allegri cani per preservare questa lunga tradizione e i meravigliosi tartufi che genera”.
 Francesco Albertelli
Francesco Albertelli