Fra crisi e bit, generazione onlife

Compro “Vigliacchi” di Amelia C., Agenzia Z editore. Leggo la sinossi:
“Non ci capite, fate domande sbagliate e le vostre risposte sono vacue. Non siete di un’altra generazione, siete di un’altra epoca. Ci parlate del vostro magnifico passato ma ci avete lasciato un presente devastato dalla guerra e dalle ingiustizie. Ci accusate di stare sempre attaccati allo smartphone, ma almeno noi lo sappiamo usare. Non avete capito che non ci interessa il colore della pelle di un nostro amico, che possiamo sperimentare l’amore con leggerezza e coscienza. Siamo maschi o femmine, possiamo scambiarci i ruoli senza essere perversi e non ci serve il porno che guardate voi. Avete un ruolo prestabilito ma non sapete più quale è il senso della vostra vita. Vogliamo essere guardati negli occhi. Vogliamo cambiare direzione milioni di volte. Noi siamo il futuro. Vogliamo sperimentare, vivere, provare, lanciarci in volo a occhi chiusi. Voi avete perso.”
Poi leggo il libro.
Poi in collaborazione con l’AI, dopo avere visto 'Adolescence', letto molti pareri, seguito tremende vicende violente nella realtà offline, decido di scrivere due righe.

Gli anni che hanno segnato l'inizio del nuovo millennio, quel lasso di tempo tra il 2001 e il 2020, sono stati una vera e propria centrifuga di eventi che hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi. Per gli adolescenti di quel periodo, e per quelli che lo sono diventati subito dopo, questo turbinio di crisi globali e l'inarrestabile avanzata della rivoluzione digitale non sono stati solo notizie sui telegiornali, ma elementi fondanti della loro stessa crescita e visione del mondo. Tutti ricordano ancora nitidamente le prime immagini che arrivavano da New York quell'undici settembre. Un evento che, all'epoca forse non pienamente compreso nella sua portata, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno ridefinito la politica internazionale e la loro percezione della sicurezza. P oi, quasi in sordina all'inizio, ma con una forza dirompente, hanno assistito all'ascesa inarrestabile della Cina, un gigante economico e politico che ha iniziato a farsi sentire sempre più forte sullo scacchiere globale.

E poi, la crisi del 2008. Anche se magari erano troppo giovani per comprenderne appieno i meccanismi finanziari, hanno percepito l'eco delle difficoltà economiche, le preoccupazioni nelle famiglie, un'ombra di incertezza sul futuro che fino ad allora sembrava una linea retta e prevedibile. Ma non sono stati solo gli eventi economici e politici a segnare la loro adolescenza. La Primavera Araba, con le sue promesse di cambiamento e le successive disillusioni, la terribile guerra in Siria con il suo carico di sofferenza e la drammatica crisi dei rifugiati che ha toccato il cuore dell'Europa, li hanno reso consapevoli di un mondo complesso, interconnesso e spesso doloroso. E come dimenticare l'ombra lunga del terrorismo di matrice ISIS, con la sua violenza cieca e la paura che serpeggiava nelle città? Proprio mentre cercavano di decifrare questo intricato puzzle globale, un'altra forza stava rimodellando le loro vite in modo ancora più pervasivo: la rivoluzione digitale. Sono nati o cresciuti con internet ad alta velocità, gli smartphone sono diventati un'estensione naturale delle mani e i social media il palcoscenico delle loro interazioni quotidiane. Il cloud computing? Beh, per loro è semplicemente "dove stanno le cose".

Essere "nativi digitali" ha aperto un mondo di opportunità incredibili: accesso illimitato all'informazione, nuove forme di apprendimento, la possibilità di connettersi con persone in ogni angolo del pianeta. Ma questa medaglia ha anche un rovescio. La pressione sociale online, la costante necessità di validazione attraverso like e commenti, il rischio del cyberbullismo e della disinformazione sono sfide con cui si sono trovati a fare i conti fin da giovanissimi. La linea tra la loro vita online e quella offline si è fatta sempre più sottile, fino a quasi scomparire, in quello che Luciano Floridi chiama il mondo "onlife". E in questo mondo "onlife", le domande che emergono sono profonde e cruciali. Come costruire la propria identità quando si è contemporaneamente presenti in molteplici spazi digitali e fisici? Cosa significa la privacy quando ogni loro interazione, ogni loro "like", ogni loro spostamento può essere tracciato e analizzato? Quali sono le nuove regole etiche da seguire in questo ambiente interconnesso, dove un commento impulsivo può avere conseguenze reali e durature? Come cambiano la politica e la società quando le informazioni viaggiano alla velocità della luce, spesso senza filtri e senza verifiche? E soprattutto, come insegnare alle nuove generazioni, a navigare in questo mare magnum di opportunità e insidie?
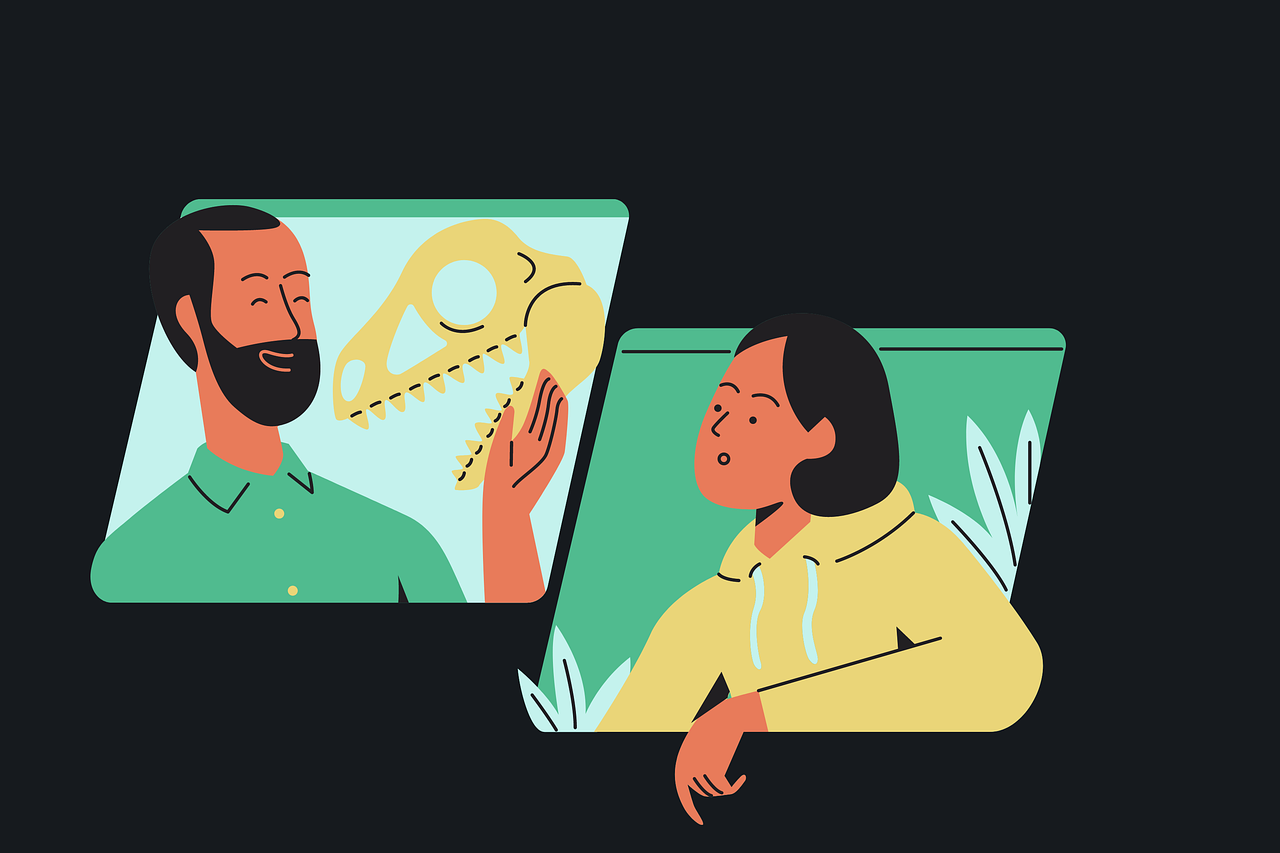
La pandemia di COVID-19, arrivata proprio alla fine di quel ventennio cruciale, ha rappresentato un ulteriore spartiacque. L'isolamento forzato, la paura del contagio, l'interruzione delle routine, hanno acuito l'ansia e l'incertezza che già serpeggiavano nelle loro vite. Hanno imparato sulla loro pelle cosa significhi dipendere dalla tecnologia per mantenere i contatti, per studiare, persino per fare la spesa. Nonostante tutto, credo che questa generazione, la "onlife", cresciuta tra crisi e bit, abbia sviluppato una particolare consapevolezza del mondo che la circonda. Sono più informati sulle questioni globali, più sensibili alle disuguaglianze, forse più esposti all'ansia ma anche più capaci di adattarsi a un mondo in costante cambiamento.
La sfida ora è trasformare questa consapevolezza in azione. Imparare a gestire la propria identità digitale senza perdere di vista la propria autenticità offline, proteggere la loro privacy in un mondo iperconnesso, sviluppare un'etica digitale che promuova il rispetto e la responsabilità, partecipare attivamente al dibattito politico senza cadere nelle trappole della polarizzazione e della disinformazione. L'educazione gioca un ruolo fondamentale in tutto questo. Devono imparare a leggere criticamente il mondo digitale, a distinguere le fonti affidabili dalle fake news, a proteggere i loro dati personali e a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e costruttivo. Devono coltivare le loro competenze sociali ed emotive, perché in un mondo sempre più virtuale la capacità di costruire relazioni autentiche e significative nel mondo reale è più importante che mai.
Sono una generazione che ha dovuto affrontare sfide enormi fin dalla nascita. Ma proprio per questo, forse, hanno anche sviluppato una resilienza e una capacità di adattamento uniche. Il mondo "onlife" è il loro mondo, e sta a loro plasmarlo in modo che sia più equo, più sicuro e più umano.
P.S. mi chiedo in che secolo viva la Corte suprema inglese.
 Maria Chiara Risoldi (foto Pixabay e archivio)
Maria Chiara Risoldi (foto Pixabay e archivio)
