Lo scorso 5 settembre a Baku, Azerbaijan, si sono concluse le finali dell’International Collegiate Programming Contest (ICPC), una competizione internazionale giunta alla 49° edizione alla quale hanno partecipato 140 squadre provenienti da 103 paesi. La Missione dichiarata della manifestazione è stimolare l’innovazione nell’informatica attraverso la competizione tra squadre di studenti universitari che si sfidano a trovare soluzioni a problemi reali utilizzando la programmazione algoritmica. In parole (molto) povere, viene chiesto loro di risolvere problemi con un computer. La classifica di questa edizione ha visto primeggiare la squadra dell’Università di S. Pietroburgo, seguita, in ordine, dalle università di Tokyo e dalle tre università cinesi di Jiaotong, Tsinghua e di Pechino. Tra le prime nove squadre ci sono anche le americane Harvard e MIT e l’università di Zagabria.

La competizione è tutt’altro che una fiera di paese. Arrivare alle finali mondiali vuol dire superare selezioni severe. All’edizione 2025 hanno partecipato oltre 73.000 studenti di 3.424 università nel mondo. Tra le 140 migliori squadre selezionate, l’Italia era rappresentata dall’Università di Pisa. Ma non è tanto la competizione la vera notizia, quanto il fatto che NESSUNA squadra di studenti è riuscita a risolvere un problema che invece è stato risolto con l’AI di GPT-5. Infatti questa edizione della competizione ha visto in parallelo la partecipazione di operatori di AI tra cui quelli di OpenAI (autori di GPT5) e di Google (autori di Gemini 2.5 Deep Think), che hanno ottenuto in diverse occasioni una performance pari e anche migliore delle squadre universitarie. Se, per secoli, il dubbio amletico sull’essere ha dato filo da torcere ai nostri pensierosi filosofi, dubbiosi sulla "raison d'être" del genere umano, oggi ad assillarci è il quesito: “Come andrà a finire?” Una domanda poliedrica, applicabile in infiniti contesti; dall’economia alle guerre, dalla cronaca quotidiana alla conduzione dei talk show. E per quanto attiene all’AI, lo stesso Sam Altman, patron di OpenAi, non ha risposta.
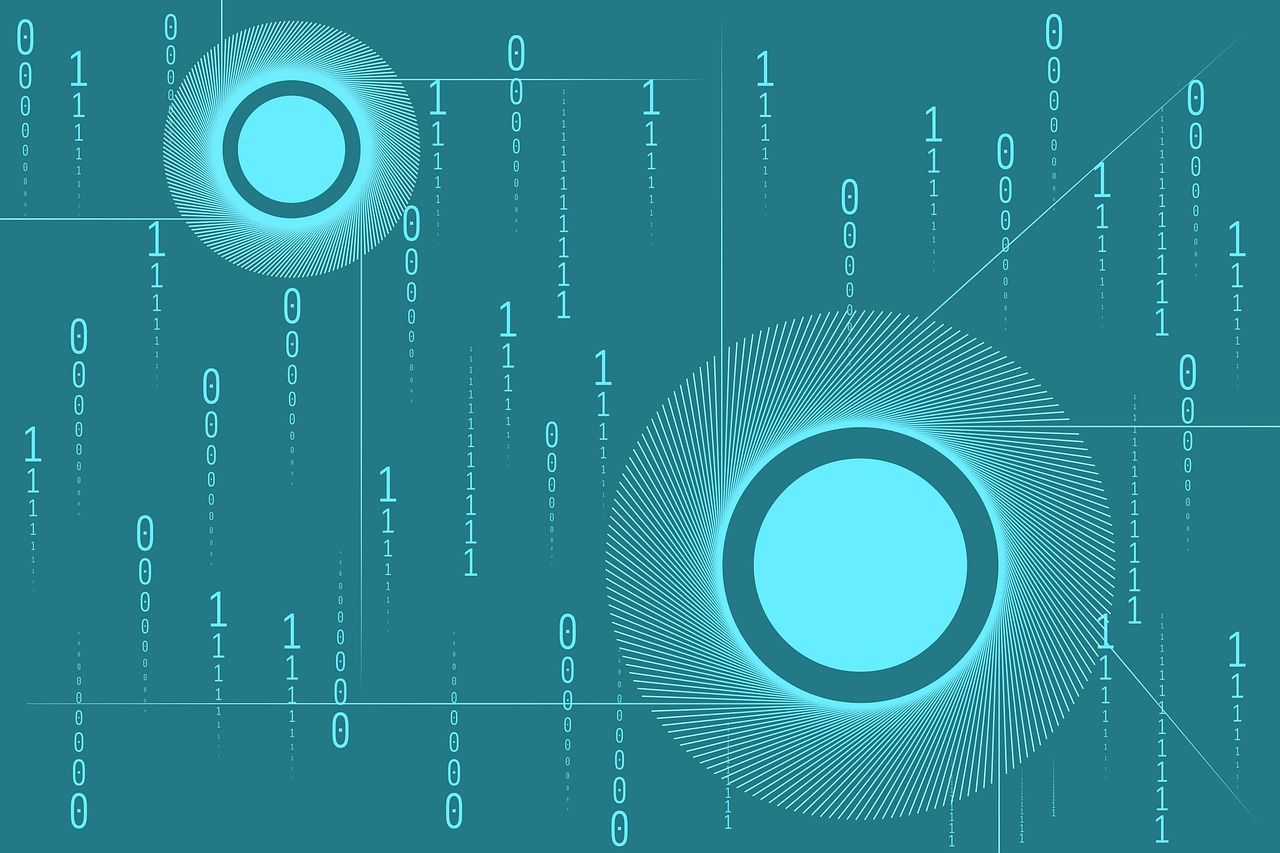
L’AI è indiscutibilmente un “megatrend” secondo la definizione di John Naisbitt: un fenomeno capace, nel lungo termine, di modellare in modo profondo le economie e le società di tutto il mondo, influenzandone abitudini, politiche e strategie aziendali, e come tale è destinata ad uno sviluppo continuo. Uno sviluppo che necessita di una infrastruttura immensa, complessa e costosa. Il giorno dopo il suo insediamento, avvenuto lo scorso 20 gennaio, il Presidente Trump ha annunciato al mondo il progetto “Stargate,” un investimento di 500 miliardi di dollari in infrastrutture tecnologiche di supporto per l’intelligenza artificiale, da realizzare dai più grandi operatori del settore, del calibro di Oracle, Microsoft, Nvidia e altri ancora. Per Trump la posta in gioco era (ed è) la conquista, la riconquista e il consolidamento della supremazia USA nella tecnologia, e non solo, da realizzare sotto l’egida del MAGA e del “proudly made in USA”.
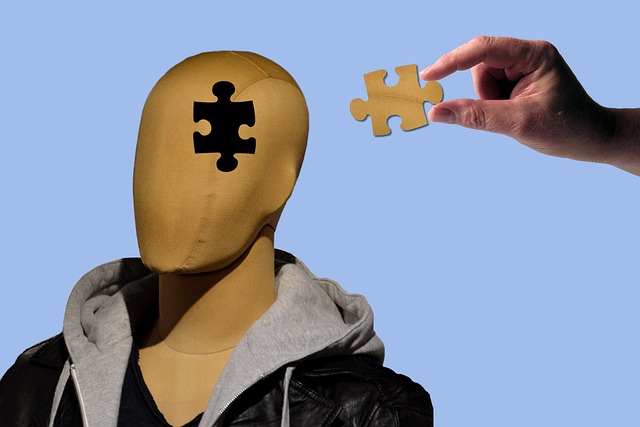
La notizia ha trovato spazio sui quotidiani per qualche giorno ma é presto sparita; eppure, quanto sta accadendo in questi giorni conferma la caratteristica di megatrend del fenomeno AI, e gli investimenti effettuati dall’inizio dell’anno a ieri sono la dimostrazione che quello di Trump non è stato solo un annuncio. Oltre ai 500 miliardi di dollari di Stargate ci sono anche i quasi 9 miliardi di dollari investiti dal governo USA nel colosso INTEL (che già oggi valgono quasi 14); i 40 miliardi di dollari raccolti in finanziamenti da OpenAI nel marzo scorso; i 15 miliardi di dollari di Meta investiti in una società di gestione dati; l’impegno di Nvidia ad investire fino a 100 miliardi di dollari in Open AI, per consentire loro di completare i data center a cui Nvidia fornirà i semiconduttori; i 5 miliardi di Nvidia insieme all’interesse di Apple a sostenere INTEL. A questi miliardi vanno aggiunti anche gli investimenti sostenuti da Microsoft e Oracle e tanti altri milioni di dollari investiti in AI da altre società sparse qua e là. Investimenti non solo in territorio USA ma anche in Europa, dove OpenAI e Nvidia stanno costruendo un data center d’avanguardia in Norvegia, e dove tutti gli operatori stanno investendo circa 40 miliardi di dollari in Gran Bretagna. Non a caso alla cena di gala di pochi giorni fa offerta da Re Carlo a Trump, oltre all’aristocrazia britannica attorno alla tavola bandita c’era anche l’élite dell’High Tech americana.
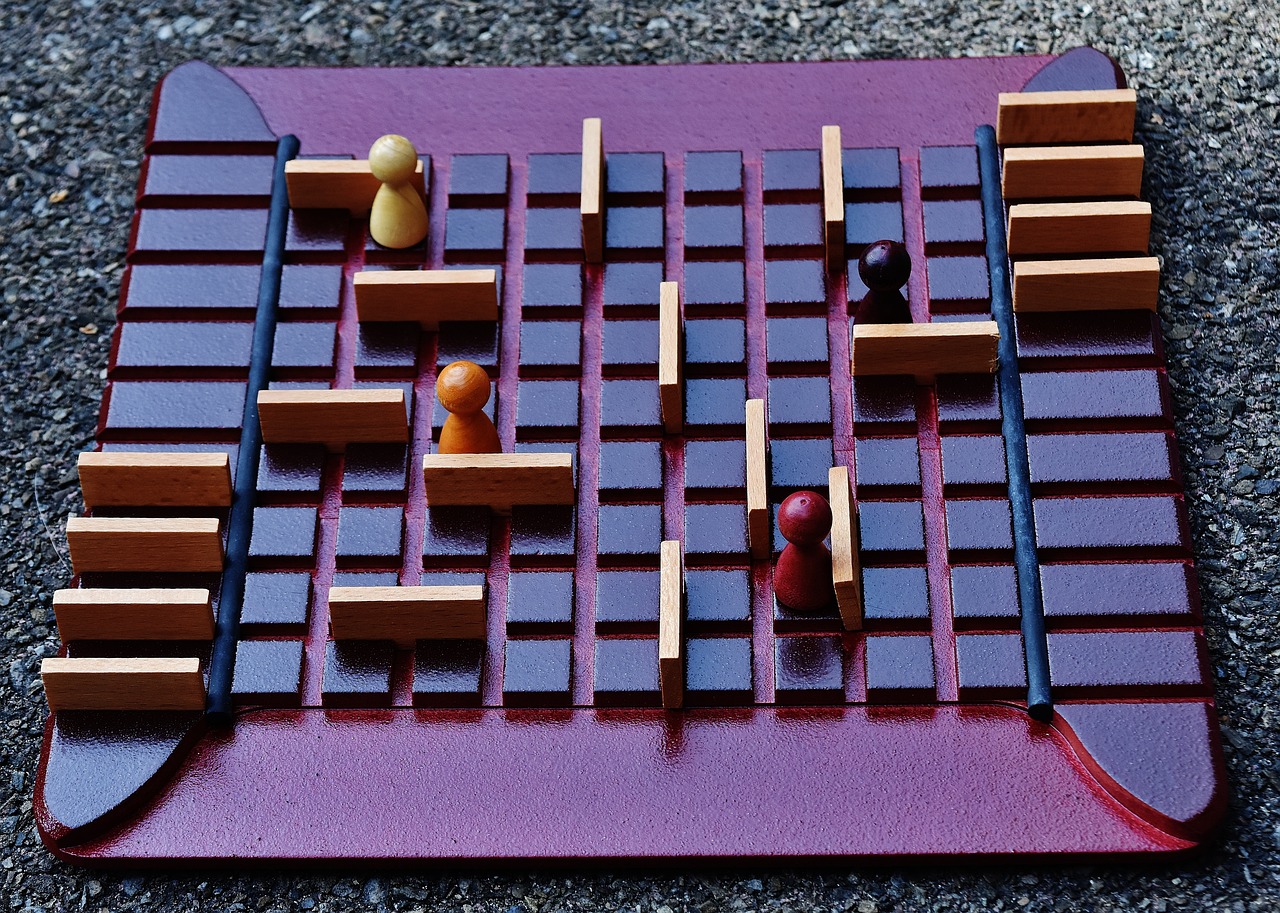
Sono tutti investimenti a forte impatto in termini di produzione, ricerca ed innovazione, in posti di lavoro, e riguardano anche lo sviluppo del settore immobiliare ed energetico, i cui effetti si tradurranno, a spirale, in altra ricerca ed innovazione, altri posti di lavoro, riverberi sui mercati immobiliari ed energetici nonché sulla stessa tecnologia energetica. Il “Sistema America” sta evidentemente rispondendo ai desiderata di Trump con una tabella di marcia così accelerata che richiama alla memoria la determinazione del “whatever it takes” di Mario Draghi. Peccato però che dalle ultime affermazioni dell’ex Presidente della BCE, sulla lentezza d’azione della UE, è ancora più evidente che il divario che l’Europa ha di fronte a sé, un divario tecnologico, legislativo, finanziario e sociale, sia probabilmente incolmabile.
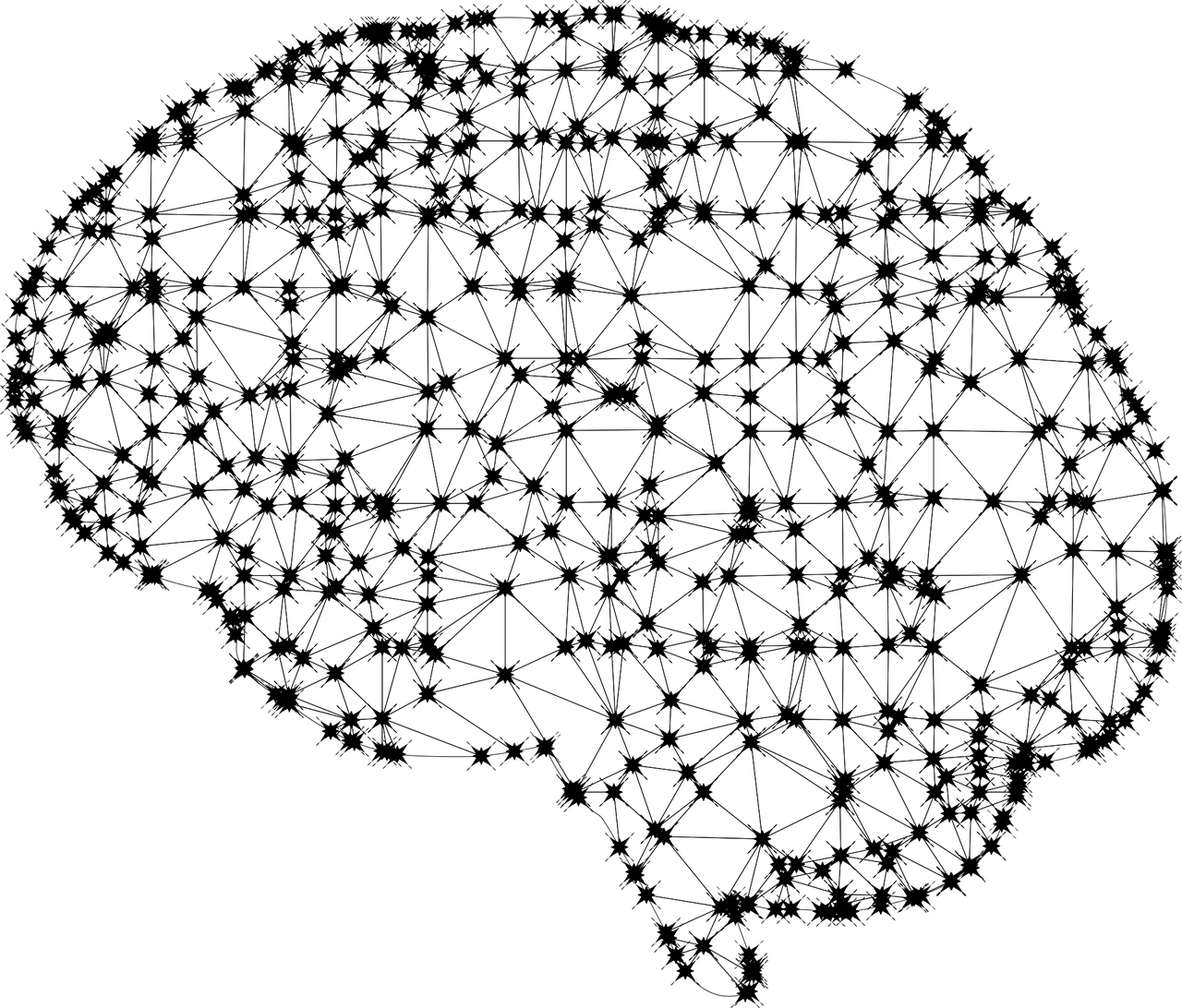
La pianificazione industriale cinese è fortemente guidata e supportata dal Governo e dalla Banca Centrale cinesi, e l’approccio ha reso la Cina il colosso industriale che conosciamo. Il metodo può piacere o no, ma siccome è il risultato che conta la supremazia di cui la Cina gode in settori strategici conferma l’efficacia dell’approccio, e il successo del lancio del programma di AI a fine gennaio scorso di Deep Seek, figlio di quest’approccio, è stato uno smacco a cui gli USA dovevano necessariamente porre rimedio. E lo stanno facendo, ma la catena del valore ha un anello debole e una misura della debolezza: l’indice “OOM”, che sta per “Out Of Memory”, mancanza di memoria. Un po' come accade quanto i nostri dispositivi non sono in grado di funzionare per una insufficienza di spazio nella memoria. L’AI deve essere prodotta. Gli applicativi, i programmi, sono solo un aspetto del prodotto finito. Certamente richiedono ricerca e sviluppo, ma hanno bisogno di ciò che si chiama “compute power”, di potenza computazionale, ovvero di tutta l’’infrastruttura che consente all’applicativo di funzionare in modo efficiente. Questa potenza comprende i macchinari dei data center, i supercomputer, le reti di fibra ottica, centrali di energia elettrica, centinaia di siti che devono ospitare migliaia di metri quadri di impianti oltre ovviamente a quanto serva per il funzionamento quotidiano: sicurezza, personale, strade etc.
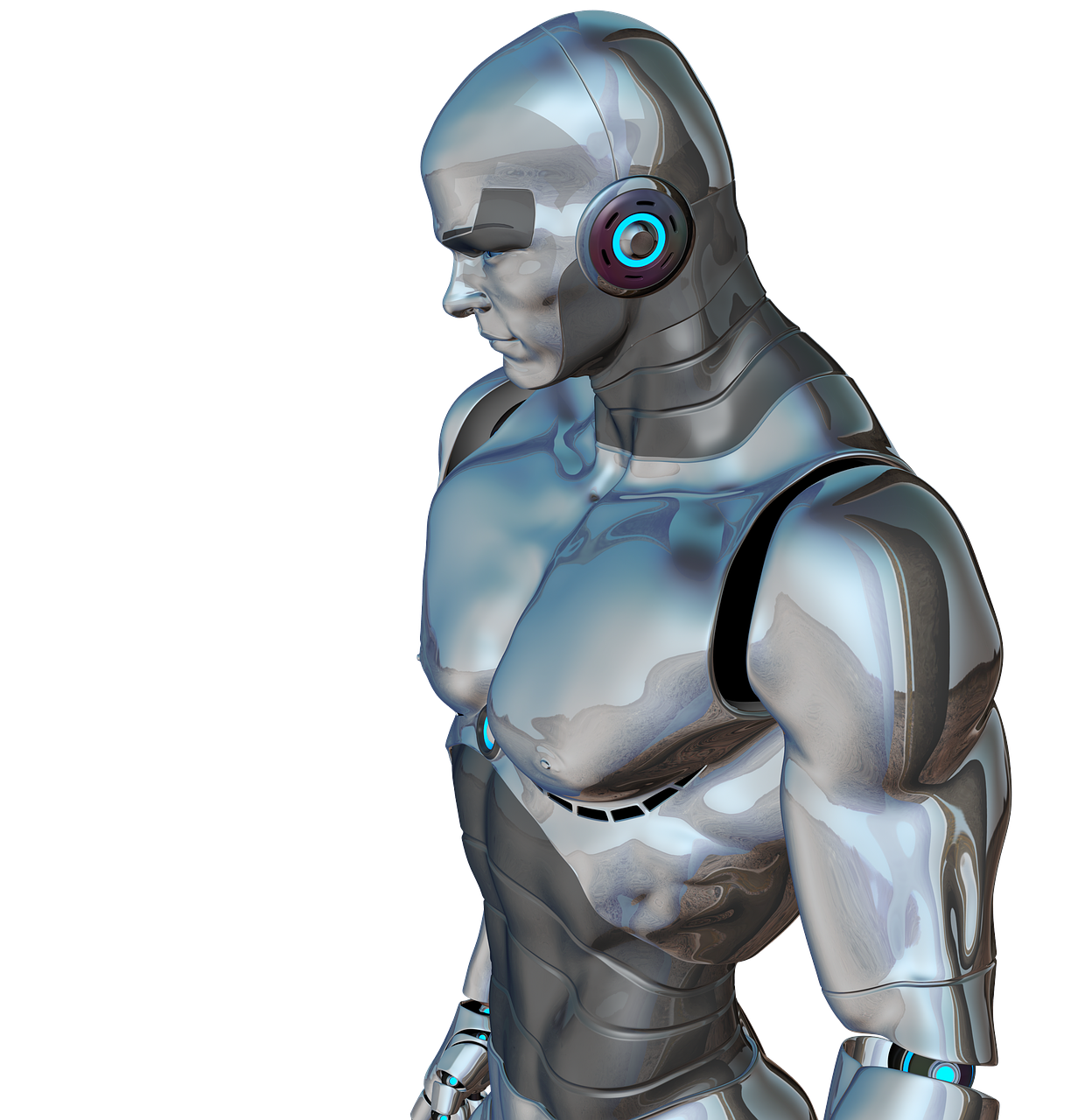
A rallentare lo sviluppo dell’AI è proprio l’inadeguatezza dell’infrastruttura esistente, ed è qui che si sta riversando gran parte dei miliardi di investimento. Investimenti che i consulenti della McKinsey stimano compresi tra 3 e 8 trilioni di dollari (3.000 – 8.000 miliardi) entro il 2030, a seconda dello scenario di domanda di AI che si verificherà. Nvidia, produttore statunitense di semiconduttori di fascia altissima, genera utili a iosa ed è quindi ricca di liquidità, nonostante la chiusura del mercato cinese imposta da Trump. Open AI continua a sfornare applicazioni di AI sempre più potenti che richiedono data center muniti di strutture informatiche sempre più performanti, che necessitano ovviamente di semiconduttori. E lo stesso vale per tutti gli altri operatori. Ecco spiegato l’accordo da 100 miliardi di dollari di Nvidia per finanziare OpenAI. Lo fa per dare una maggiore spinta allo sviluppo di applicativi, che a sua volta trascinerà un ulteriore sviluppo di altri data center e quindi la produzione di semiconduttori, innescando la spirale di cui sopra. E questa spirale si porta dietro anche Oracle, leader nella progettazione e realizzazione di data center, Microsoft, Google etc., il mercato immobiliare, dove gli impianti vanno realizzati, nonché l’enorme indotto che ne segue.
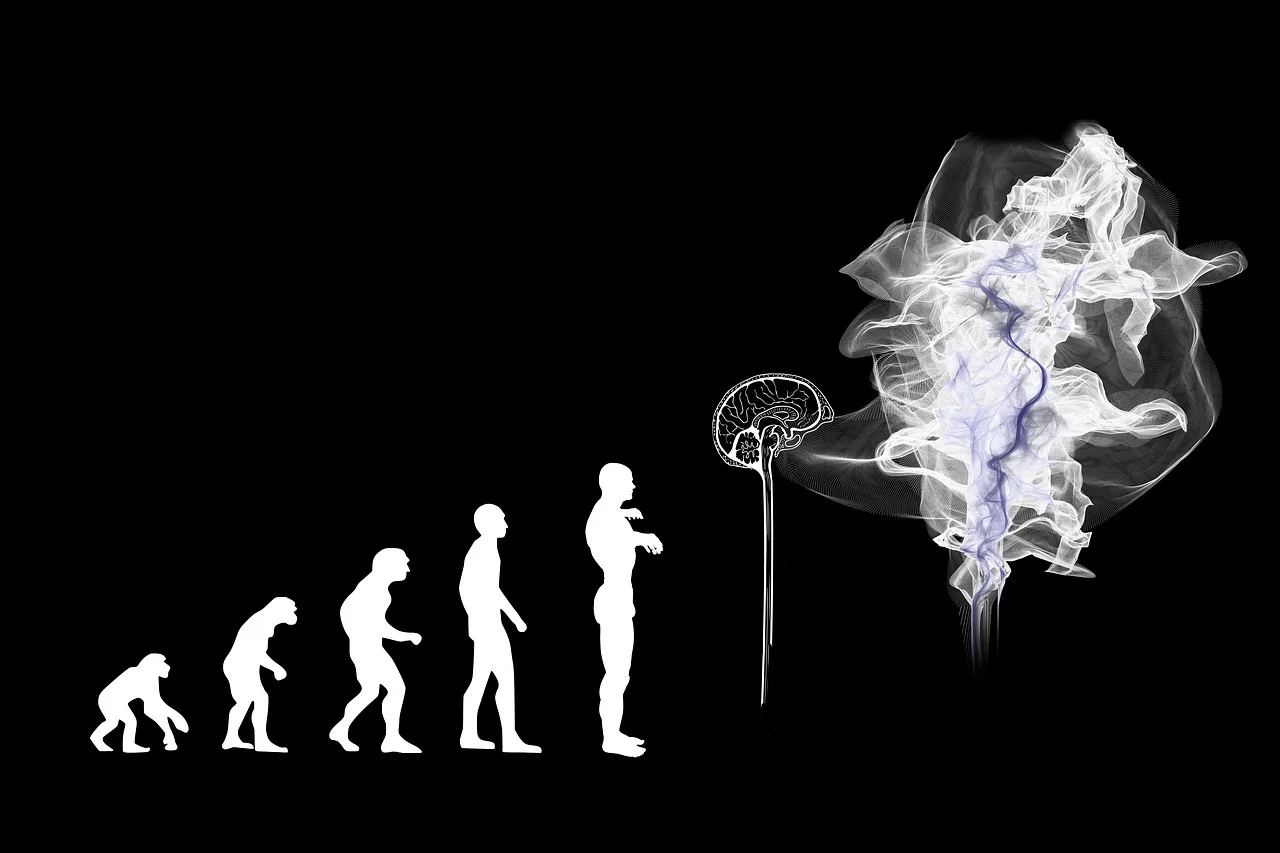
Le intenzioni sono talmente serie che sia Nvidia che il Governo USA sono intenzionate anche a “salvare” INTEL e riportarla agli antichi splendori. Il “nemico pubblico numero uno” è ovviamente la Cina, ma ad essere trascinati nella sfida sono tutti gli altri produttori di semiconduttori come la coreana Samsung, la taiwanese TSMC e l’olandese ASML, che a loro volta trascinano tutti gli utilizzatori di semiconduttori, dalla Apple alla Candy. Il timore che si stiano gettando le basi per una prossima bolla speculativa è già diffuso. Le quotazioni dei titoli azionari dei protagonisti nel settore oscillano anche di svariati miliardi di dollari al solo annuncio di accordi presi o promesse di acquisto fatte. Altri invece pensano che non si possa parlare di bolla per il solo fatto che non si ha alcuna conoscenza di tutte le potenzialità dell’AI. Manca una dimensione del “business” che comunque è già immenso.

Stiamo vivendo una rivoluzione epocale dove le poste in gioco sono altissime e dove i protagonisti sono gli artefici di smisurate ricchezze in termini economici, di conoscenza e di tecnologia. Otto delle prime 10 persone più ricche del pianeta provengono dall’High Tech e posseggono patrimoni dal valore superiore ai 2 trilioni di dollari (2.000 miliardi). Una ricchezza in grado di acquistare più di 50 volte la produzione annuale di grano. Le potenzialità sembrano davvero infinite. Dalla semplice AI che compie elementari istruzioni, ci stiamo incamminando verso una intelligenza artificiale generale (AGI), un approccio che sta tentando di creare software dotato di un'intelligenza simile a quella umana, con capacità di autoapprendimento in modo che possa eseguire attività per le quali non è stato specificamente addestrato. E se questo non bastasse, OpenAi è già lanciata nello sviluppo di una “superintelligenza” artificiale: un agente che supera l’intelligenza umana in ogni aspetto, dalla creatività alla risoluzione di problemi. Come se l’AGI fosse un’intelligenza a livello umano e invece la ”Superintelligenza” fosse sovraumana.
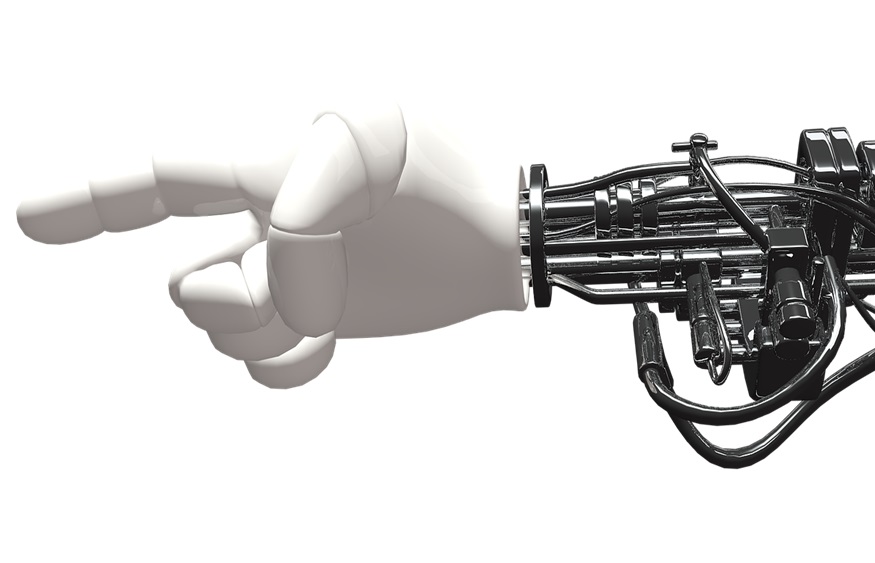
La corsa è partita e di sicuro non si fermerà e la l’AI “ultra intelligente” potrebbe essere l’ultima invenzione che il genere umano farà. Al momento i vari Stati sono più osservatori che protagonisti in questa corsa, ma i data center sono vitali per la “sicurezza nazionale”, e non solo in termini fisici, economici o militari. In palio c’è tutto ciò che un uso inappropriato di dati e di informazioni può creare. È curioso che questa politica industriale americana rispecchi molto quella degli interventi di spesa pubblica di stampo keynesiano a sostegno dell’economia. Abbinata ad una politica monetaria espansiva potrebbe effettivamente essere un motore propulsivo, che potrebbe davvero “Make America Great Again.”
 Luigi Epomiceno
Luigi Epomiceno


