Poche sono le morti che riescono a farci rivenire davanti i frammenti d’immagini più antichi e dare loro un senso. La morte di Goffredo è, per me, una di queste.
Ero molto piccolo. Vedo una bufera di neve fitta fitta, il braciere acceso, il tavolo con la tovaglia piena di briciole, piatti e bicchieri e le voci che si accaldano nel dibattere serale, un vociare costante, pieno di parole che non conosco e che ripeto ad alta voce gironzolando per le stanze, chiedendone il significato a una o all’altro, inutilmente.
Era una delle mie perenni famiglie allargate, che si intrecciavano secondo geometrie cambianti. Lì ci sono mio fratello piccolissimo, mio padre Manlio e mia mamma Annie, Angela Zucconi, Mimma Trucco, mia sorella Marina, le mie cugine, qualcun altro che non so e Goffredo. Goffredo mi porta alla finestra a guardare i fiocchi sempre più grandi.
Goffredo ci sarà molte volte. Lo ricordo che ero bambino sulla Sila, a Tricarico, nella Bari vecchia e, poi a Napoli tante volte e una, nel dicembre del 1980, nella quale mi “cazziava” davanti a Fabrizia Ramondino, che rideva beata per qualche mia ignoranza pedagogica e poi mi invitava a scrivere quel che vedevo succedere nella mia terza classe in un container dopo il terremoto.
Solo dopo anni ho capito la scena della neve. Eravamo a Pescocostanzo, in Abruzzo, era il 1960, avevo 6 anni. Vi si andava d’estate. Ricordo le immense querce secolari. Ma quella volta era inverno. Goffredo aveva 23 anni. Era lì impegnato nella ricerca, famiglia per famiglia, per capire le scelte di una comunità tra spinta ad emigrare e fatica di restare nell’appennino meridionale. La ricerca sul campo era parte costitutiva della scuola che frequentava. Goffredo era lì sotto la guida di Angela Zucconi, la grande traduttrice e studiosa di Kierkegaard, che subito dopo la guerra fondò il CEPAS, la prima scuola non confessionale del servizio sociale italiano.
La scuola e quelle prime ricerche sul campo multi-disciplinari furono la culla culturale nella quale Goffredo si formò. Sono la matrice del suo piglio anti-ideologico, del suo argomentato posizionamento radicale ma esplorativo, del suo testardo rifiuto dei cliché, della sciatteria, del dogma. È all’origine del suo intransigente appello a non omologarsi e, al contempo, a curare un metodico confronto tra temi, discipline e impeti volti all’impegno.
Goffredo approdò al CEPAS dopo essere stato giovanissimo maestro elementare nella sua nativa Gubbio, con in mente gli scritti di John Dewey e la pedagogia empirista democratica statunitense, Tristano Codignola, il grande pedagogista liberal-socialista italiano, e la militante svizzera dell’Internazionale Socialista Margherita Zoebeli, che fondò i centri educativi più innovativi d’Europa, dedicati ai bimbi delle famiglie sfollate e operaie, rese misere dalla guerra.
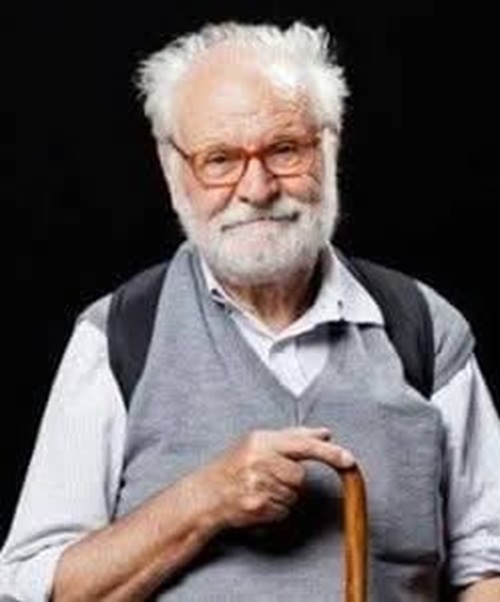
Goffredo ragazzo nel mio tempo da bambino era alla ricerca di come si fa ricerca sociale, quella non solo per capire e, certo, non per fare accademia, ma per cambiare le cose. Quella scuola si era costruita, attraverso gli anni Cinquanta, entro un dibattito culturale tra i più densi e innovativi della nostra storia. Un dibattito – che veniva avanti dagli anni dell’antifascismo clandestino, dalla Resistenza e dalla Costituzione - sulle forme e prospettive del modello di sviluppo italiano, tra fine del mondo contadino, migrazioni di massa interne (Goffredo curerà una straordinaria inchiesta sull’emigrazione meridionale a Torino) ed esterne, ricostruzione civile e non solo fisica, boom industriale poderoso, nuovo meridionalismo, nuovi conflitti e nuove forme di arte.
Goffredo faceva spesso notte tarda, come allora si usava, tra maestri e giovani. Il confronto era fitto ed era tra mondi diversi di sapere, che si ascoltavano. I nomi di alcuni dei suoi maestri ci raccontano bene lo spessore dell’apprendistato di Goffredo Fofi. Guido Calogero, grande studioso della logica antica, allievo critico di Ugo Spirito, filosofo del dialogo e sua moglie Maria Comandini, co-fondatrice del CEPAS. Aldo Capitini, il padre del gandhismo italiano, impegnato nei centri di orientamento sociale e nell’elaborazione dei primi modelli di decentramento democratico partecipativo. Adriano Olivetti, la sua frontiera di una nuova impresa e il Movimento di Comunità. Rocco Scotellaro, Carlo Levi, Rocco Mazzarone, la prima Svimez, la scuola di Portici, mio padre.
Nel guardare questi contesti, dove Goffredo si è formato, si fanno chiari il suo posizionamento e il suo timbro. Si tratta, infatti, della rete generativa del migliore pensiero democratico, critico ed operativo, che univa, poliedricamente, molte discipline, che aveva un’ispirazione cosmopolita, che provava a contrastare le italiche esacerbate e riduttive polarizzazioni (tra democristiani e comunisti, tra occidentalismo e sovietismo, tra capitale e lavoro, tra sviluppo e sottosviluppo, anche tra credenti e non credenti). Era un vero cantiere che allora era faticosamente all’opera, stretto come un vaso di coccio tra vasi di ferro, come la vicenda nazionale tristemente racconterà…. Un cantiere di pensiero, analisi, proposta, impeto civile che si muoveva su di un crinale stretto, tra poli contrapposti, per tentare di dare alla Repubblica il telaio culturale indispensabile per poter creare modelli di sviluppo integrato, fondati sulla crescita culturale dei cittadini e sul benessere non solo legato al PIL, coniugando tenuta sociale e civile, sviluppo produttivo equilibrato tra industria e agricoltura, benessere delle persone.
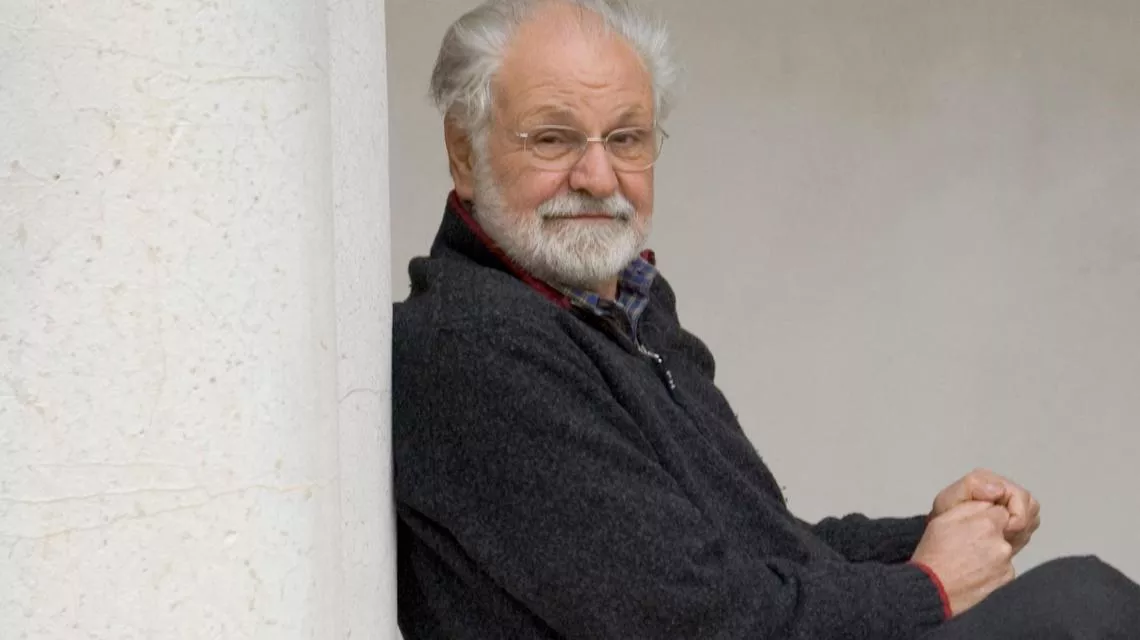
Di quella stagione Goffredo parla nel suo bel libro “Strana gente”. Il libro riprende il suo diario “ritrovato” proprio del 1960, l’anno nel quale si era allontanato in modo motivato dall’esperienza con Danilo Dolci nelle baracche di Palermo e nel borgo di Partinico per diventare assistente e ricercatore sociale esperto.
E, intanto, Goffredo divorava romanzi, teatro, musiche, fumetti e film di ogni dove mentre attraversava l’Italia in treno, avanti e indietro, parlando con tutti di tutto. Intorno era caduto il governo Tambroni per la spinta di un moto popolare, la tensione tra Est e Ovest aumentava, usciva La Dolce Vita di Fellini, moriva Fausto Coppi.
Gli eventi di ogni tipo, i segnali creativi, le passioni, i mestieri, i dialoghi vivi: tutto si è ri-unito – allora e fino alla morte – nella passione culturale e civile di Goffredo. È questa spinta che scruta ovunque che ha destato riviste, aggregazioni, movimenti, incontri tra persone le più diverse. Tutto – credo – per lui ha avuto un centro politico ma mai partitico. Goffredo ha avuto un’ispirazione di mezzo tra miglior anarchismo e pensiero “liberal socialista”: la intransigenza contro le ingiustizie e contro ogni cosa che allontana le persone dal poter contare nel mondo. Qualcosa che non poteva essere confessionale né comunista. Così, del potere Goffredo diffidava. Si teneva a distanza, evitava di esserne preso e anche di misurarsi. Criticava qualsiasi tentativo anche di “ragionevole mediazione” con gli assetti dominanti e diffidava delle istituzioni perché ferme, stabilite, usabili da chi è più forte. Questa ispirazione inamovibile è stata la sua forza, il suo prestigio, la sua debolezza, il suo lascito. Altro che “fine intellettuale critico”! Una voce così ci mancherà eccome.
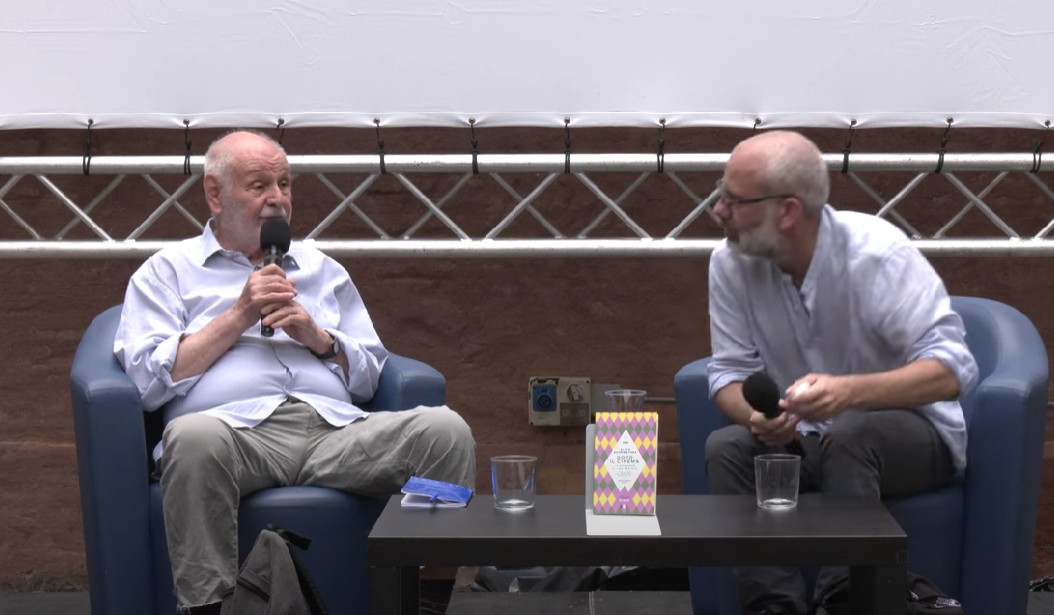
Avere e mantenere l’amicizia con Goffredo è stato un privilegio, un dono e una fatica. Non era facile volergli bene tenendogli testa e viceversa. Ma è stata una benedizione: la quantità di suggerimenti e suggestioni su cosa studiare, visitare, fare e leggere è di una dimensione irraggiungibile. È l’esperienza vissuta da migliaia di persone che, anche grazie a lui, continuano a tessere, sbagliando e ripensando, reti di senso in un mondo ingiusto. Tante persone – la ‘strana gente’ - che oggi sono tristi e che lo ringraziano.
 Marco Rossi Doria
Marco Rossi Doria


