Ho cominciato a contare gli anni da quel settembre. Oggi il cielo sopra Manhattan è azzurro e trasparente come allora, il parco è pieno di voci, l’acqua corre nella grande vasca ricavata dalle fondamenta delle due torri. La nuova torre, sottile e affilata, corre verso l’alto e sfolgora al sole. Sul bordo di pietra della piscina, tra le decine di nomi scolpiti in lettere d’oro cerco - e alla fine trovo – quello di Alejandro Castano. Allora, nella polvere dei detriti, la ragazza Claudia Castano, poco più di una bambina, si inginocchiava davanti ai soccorritori, implorava: “Cercate mio fratello, cercate nel tunnel, forse è ancora vivo, tanti sono scesi nel tunnel, dopo l’esplosione.”

Sono trascorsi ventiquattro anni: oggi l’America vive lungo la West Side Highway, dove allora correvano a sirene spiegate i camion delle squadre di soccorso. L’America vive tra Liberty, Church e Fulton dove la gente piangeva inginocchiata, abbracciata agli uomini schiantati dalla fatica in cerca di corpi tra le rovine. L’America vive oggi, ma non vive Alejandro Castano, detto Alex, e non vive Steven Morello, di cui già allora restava solo una foto che stringeva il cuore, incollata a una vetrina e già sbiancata dal sole. Ventiquattro anni: questi nomi stampati sul bordo della vasca – centinaia e centinaia – sono il libro mastro del grande vascello di pietra che da generazioni separa il pianeta da un oceano all’altro. Sono Pak Chin Sun, Ronald Kloepfer, Sandra Teague. E ancora Scott Kopitko, Lee Yang Der, Virgilio Lawrence, Charles Aaron: i latini e gli asiatici, i bianchi e i neri, i tedeschi e gli ebrei e gli italiani.
Si disse allora: l’ America “ha perso la sua innocenza”: come sa essere brutale e falsa la retorica del giorno dopo! L’America non è mai stata innocente. Come tutti gli imperi ha dominato, ha tramato, ha soggiogato, ha scatenato guerre sanguinose. Invece, e piuttosto: molto amata, e più spesso odiata, l’America non è mai stata sola, e non sono mai stati soli gli americani: quella matassa meticcia e inestricabile di milioni di storie, di esistenze, di speranze e dolore e trionfi che danno forma alla storia di un grande paese. A New York, come in uno specchio, questa America si riflette nel profilo geografico della sua più grande icona vivente. In linea retta da Ovest ad Est, camminando da quella che ventiquattro anni fa era la voragine delle Torri gemelle, arriviamo al numero 97 di Orchard Street, dove un piccolo, straordinario museo rivela la vita quotidiana di migliaia di immigrati che in questo misero quartiere vissero per generazioni, dalla metà dell’ottocento ai primi decenni del nuovo secolo: bianchi d’ Europa, italiani e irlandesi, spagnoli e catalani, ebrei galiziani, russi e polacchi.

Tenement è la casa, il condominio, il casermone, la cucina fuligginosa, lo sgabuzzino del cesso in comune e il pagliericcio minuscolo, le povere camere separate da un lenzuolo appeso al soffitto, la cuccia dove intere generazioni di immigrati strappavano a bocconi la vita e formarono l’America di oggi. E ancora: camminando da Est ad Ovest, sotto Little Italy e lungo Canal, ecco Chinatown: la mercanzia esposta lungo il marciapiede, il mercato ininterrotto, il brusio dell’Oriente, il parco minuscolo dove vecchi centenari e silenziosi giocano a mah-jong su logore panchine. Sono i pronipoti dei cinesi che nella seconda metà dell’Ottocento arrivarono in massa, deportati, per lavorare ai piedi della poderosa First Trascontinental Railroad, la ferrovia destinata ad unire la lontana costa atlantica con la California e l’Oceano Pacifico. Per questa terribile impresa, attraverso i massicci della Sierra Nevada e i deserti dello Utah, in estati torride e inverni nevosi, i baroni della ferrovia reclutarono dal lontano oriente gli ultimi degli ultimi, più schiavi che lavoratori: cavatori di pietre, manovali, lavandai e servi domestici tuttofare. In breve la popolazione cinese della California sfiorò la cifra di centomila anime. I gialli posavano rotaie, scavavano montagne e alzavano dighe, furono operai e giardinieri e spazzini.

In un diario, un testimone dell’epoca scrive che i cinesi “sembrano disposti a fare tutti i lavori che la nostra gente non può o non vuol fare.” E ora dritti a nord, all’incrocio tra Lexington Avenue e la 104th East, dove un gigantesco murale occupa l’intera facciata di una vecchia brownstone. Il grande affresco – “The spirit of East Harlem” – racconta un giorno qualunque della vita degli immigrati latini a New York nei lontani anni Cinquanta: una interpretazione iperrealista, con bambini che giocano in strada, massaie che lavorano in casa, giovani che amoreggiano, anziani che ciarlano o si sfidano a domino sulle panchine del parco. Un qualunque giorno sereno in questa New York meticcia racchiusa tra due frontiere: a sud e lungo l’East River la città del lusso e dei bianchi ricchi, in alto ad ovest l’antico ghetto dei neri, così cambiato dai tempi feroci della segregazione e della guerra civile tra la polizia armata e le milizie delle black Panthers. Dentro il barrio si parla spanglish e si mangia piccante, ma i giovani vogliono essere orgogliosamente americani.
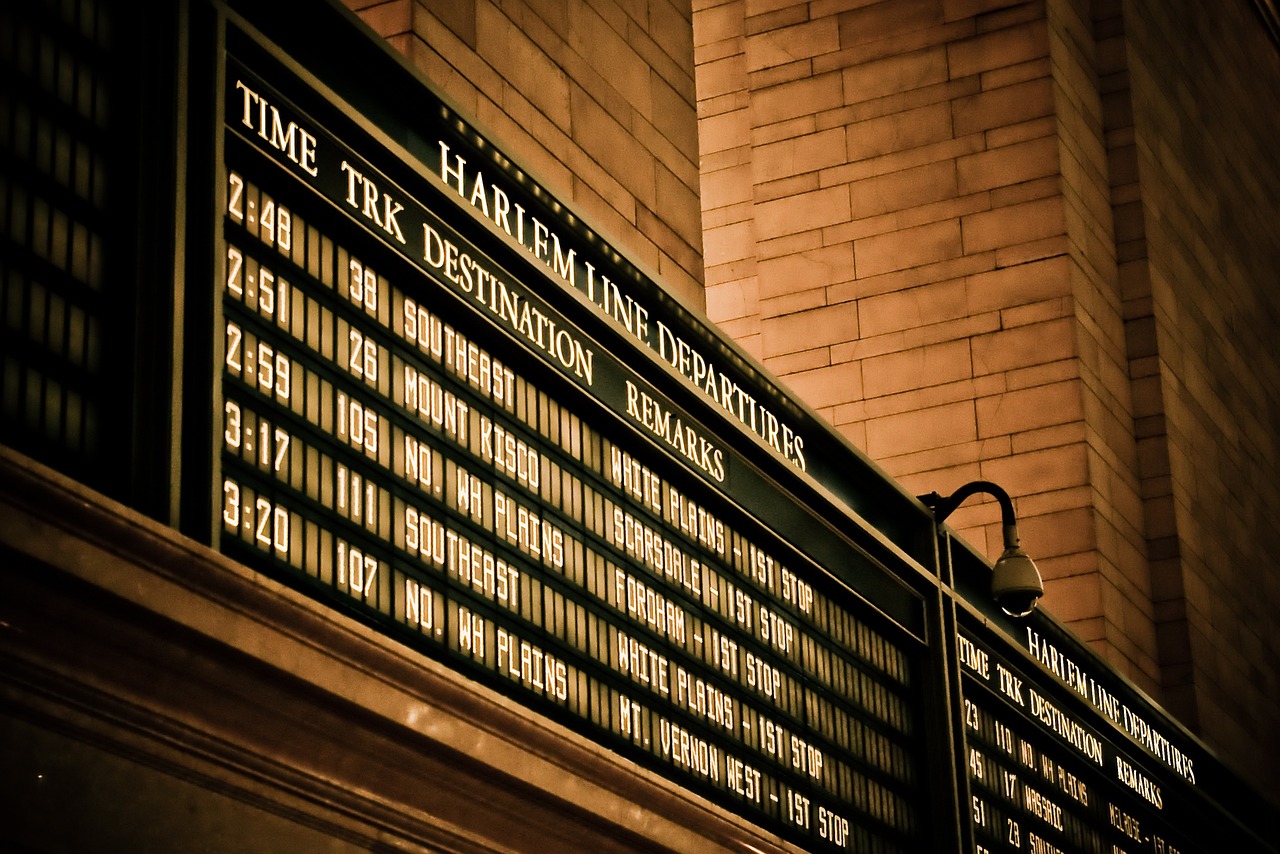
Anche questo ritratto domestico è un racconto di frontiere: negli ultimi anni della seconda guerra mondiale l’America bianca – il Norteamerica di Franklin Delano Roosevelt – aveva urgente bisogno di mano d’opera, che arrivò con una valanga di contratti a tempo soprattutto dal grande bacino messicano. Erano i cosiddetti braceros: in gran parte contadini e operai, affamati e volenterosi. “Appena arrivati qui – dice Luìs – al barrio che ancora non si chiamava barrio, mio padre ebbe la buona idea di mettere incinta mia madre. Arrivai io, e poi tutti gli altri…” E che dire di questa metropoli dell’Occidente all’alba del secolo scorso? Scrive l’ emigrante ebreo-polacco approdato a New York: “Broadway non era mai sembrata tanto caotica e sudicia. Puzzava di asfalto squagliato, benzina, frutta marcia, escrementi di cane. Dal cielo fiammeggiante calava una polvere dorata. Uomini dalla camicia macchiata di sudore ingollavano succo di ananas e di papaia come per spegnere un fuoco che li consumava dentro. In una strada laterale bambini neri e bianchi avevano aperto un idrante e sguazzavano nudi nel canale di scolo. Il tratto di strada tra Riverside Drive e Broadway diventava ogni giorno più rumoroso e sporco. Orde di monelli correvano in giro seminudi, uomini dalla pelle scura e gli occhi spiritati litigavano in spagnolo con donnette perennemente gravide...”

Questa è la città che descrive Isaac Bashevis Singer: meticcia e festosa, dolorosa e caotica, non diversa da Mumbay, Kinshasa o Mexico City. Questa era allora ed è oggi New York: non l’oro sfacciato della Trump Tower, ma la fitta trama dei quartieri e le minuscole patrie che si sovrappongono nel tempo, l’immigrato che diventa cittadino, la lingua bastarda, lo sforzo quotidiano del vivere nel ghetto e del sognare fuori dal ghetto. Moltiplicate per cento e per mille, aggiungete le altre grandi città e gli Stati, le contee e poi i villaggi e le campagne, i porti e le lunghe frontiere di terra: la trama inestricabile della storia, i popoli in eterno movimento. Oggi – a 231 anni dal primo censimento della popolazione indetto dal presidente Washington - gli Stati Uniti d’America appaiono come un Paese sempre più multietnico. I bianchi sono fermi al 60 per cento, con il 19 per cento di ispanici, il 12 per cento di afro-americani, il 6 per cento di asiatici in tumultuosa crescita. Il residuo 3 per cento si dichiara appartenente ad altre etnie, forse quelle aliene che secondo il nuovo presidente americano si sono fatte sorprendere a “mangiare cani e gatti” a Springfield, Ohio.

Quella tra l’America e la sua gente è una storia d’amore. Spesso tragica e miserevole, come tutte le vere storie d’amore. Considerate “Back in the Usa”, l’inno del ritorno a casa che un figlio di schiavi - il nero, nerissimo e scandaloso Chuck Berry - intona negli anni sessanta: “Mi sono mancati i grattacieli, mi è mancata la lunga autostrada! Mi sei mancata, America, dalle coste della California alle rive del Delaware. Ci puoi scommettere che mi sei mancata, finchè non sono tornato a casa…”. Tutta l’America è casa, e l’unico che oggi sembra non saperlo è l’uomo eletto presidente: un vecchio, ridipinto erede di immigrati tedeschi. Per dirla con Philip Roth: “Il bancarottiere al comando, l’uomo che possiede un vocabolario di settantasette parole, in una lingua preistorica che è più appropriato chiamare cretinese, piuttosto che inglese…” “Io sono moltitudini”, scriveva Walt Whitman. Misurate la desolata solitudine del bianco invidioso che oggi bivacca nell’appartamento presidenziale a fronte di questa straordinaria rivendicazione di fratellanza.
 Flavio Fusi
Flavio Fusi


