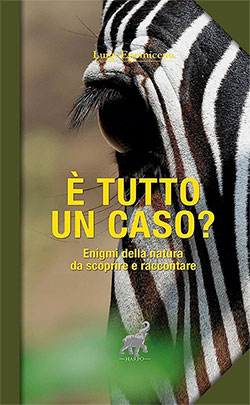Il nuovo saggio di Marco Albino Ferrari “La montagna che vogliamo” (edizioni Einaudi, Collana le Vele, pp. 144 €13,00) uscito di recente in libreria, propone una riflessione sul futuro delle terre alte, affrontando tematiche ambientali, sociali e culturali legate alla montagna italiana, in un momento in cui è minacciata dal cambiamento climatico e dall’eccesso di turismo.
Come afferma lo scrittore, “quando si parla di montagna prevale un'idea stereotipata: lo spazio dello sci, delle vacanze nelle solite località del turismo. Ma le terre alte sono anche altro. E diventeranno sempre più un laboratorio di innovazione per riconciliarci con l'ambiente e ripensare le relazioni umane. È venuto il momento di stilare un manifesto, di dire forte e chiaro qual è la montagna che vogliamo.”

Il libro ha un respiro collettivo e si evince dal titolo. Ferrari usa il plurale ‘vogliamo’ interpretando un’idea condivisa da un numero crescente di persone, giornalisti, scienziati, studiosi e abitanti della montagna, mettendo in luce il carattere complesso delle nostre montagne, dalle Alpi agli Appennini.
Marco Albino Ferrari è scrittore e giornalista, un punto di riferimento per la divulgazione della cultura alpina. Negli anni Novanta ha diretto la rivista ‘Alp’; nel 2002 ha ideato, e poi diretto per anni, ‘Meridiani Montagne’ ed è stato direttore editoriale e responsabile del settore Cultura del Club Alpino Italiano. Ha collaborato con La Stampa e altre testate giornalistiche.
Descrive le montagne italiane come un mosaico di differenze e una continua variazione di scenari e culture, che alternano grandi silenzi a intensi affollamenti.

Gli esempi che racconta sono tanti. Uno per tutti: “In Val di Fiemme la comunità è talmente viva da essere percepita non solo in senso orizzontale, come relazione tra vicini, ma anche in senso verticale con chi c’era prima e con chi verrà… La tradizione non si improvvisa. Dobbiamo guardare a una nuova forma ibrida e progressiva di comunità, intesa come alternativa a una società di singoli, una ‘comunità di intenzione’ il cui senso di appartenenza è dato da un obiettivo di scopo, dal fare, dalla creazione di interessi condivisi, anche e soprattutto materiali; dunque basata sulla ragione più che sulla tradizione.”
Il libro evidenzia con chiarezza la necessità di concentrare l’attenzione sul rapporto uomo-ambiente per favorire una presenza antropica indispensabile, ma più equilibrata.
"Dobbiamo imboccare strade percorribili, coraggiose e davvero radicali. E la montagna in questo può venirci incontro, perché è lì, nella cultura della misura e del risparmio, nella concretezza dell’esperienza diretta, che c’è la via di uscita a questa distruzione del pianeta".
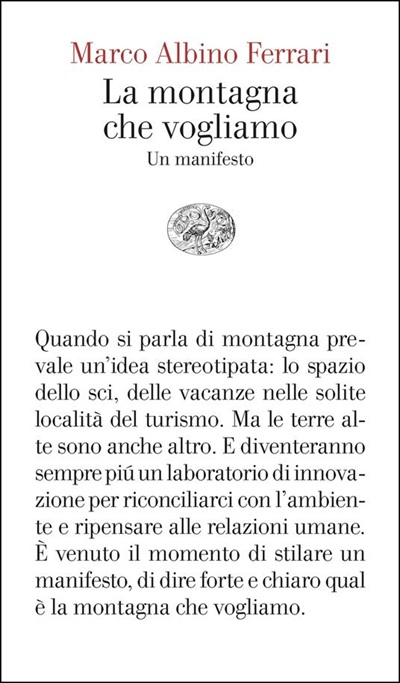
L’assenza di scelte politiche nell’adottare azioni in questa direzione significa frenare il progresso.
Ottanta, cento anni è più o meno la vita di un uomo, sono tre generazioni; potrebbe diventare una sorta di unità di misura, un ‘metro temporale della sostenibilità’ utile a distinguere ciò che è davvero sostenibile da ciò che non lo è. Ad esempio, fra ottanta, cento anni servirà ancora il nuovo impianto a fune per lo sci? Esiste un piano per riconvertirlo a qualche altra funzione o resterà solo un relitto che sfregia il paesaggio? E ancora: fra ottanta, cento anni potremo apprezzare gli effetti dei teli geotessili che oggi usiamo per proteggere i ghiacciai dai raggi solari?
Ferrari usa lo sguardo in una continua successione di piani, dalle mucche che pascolano alle praterie d’alta quota, fino al versante glaciale verso le vette più alte. “Tutto risponde a una disposizione compositiva creata a uso del turista in fuga dalla città. E se aprissimo gli occhi? Cosa c’è oltre a questa e altre cartoline della montagna ludica, con le piste di sci innevate, i rifugi alpini (oggi stellati), le grandi foreste dove aleggia lo spirito della wilderness come in uno spicchio di Alaska nostrano? Qual è la realtà?”
Usare lo sguardo lungo significa pensare alle generazioni future.
La natura, oggi, è diventata una sorta di nuova religione e gli alberi antropomorfizzati dei nuovi idoli. Se contrapposta all’uomo, si rischia di semplificare, travisare e polarizzare. Un esempio: l’eco-populismo per cui le piante non si tagliano, punto e basta, sembra un’idea rivoluzionaria e radicale. In realtà è talmente inattuabile e idealistica che non può che condurci alla continuazione dello status quo.
I territori montani dovrebbero diventare degli spazi di innovazione da non contrapporre alle città. “Non si possono osservare le montagne se non le si mette in relazione con ciò che per secoli è stato considerato il loro rovescio: la città.”
Le città sono sempre state dei potenti inneschi culturali, ma ridurre la montagna a funzione ricreativa per il weekend, a luogo del pittoresco o dello sport, significa schiacciarla in un ruolo subalterno. Oggi la congiuntura è favorevole alla creazione di un ‘nuova montagna’ come laboratorio di buone pratiche che potrebbero essere esportate in città.

È necessario capire che sotto la spinta dei cambiamenti economici, politici e climatici l’apporto all’innovazione è destinato a fondersi in una sorta di complementarietà tra montagna e città; là dove più forte è stato lo spopolamento, dove sono meno presenti infrastrutture turistiche pesanti, sarà più forte l’innesto di nuove comunità basate sulla tutela ambientale.
Il lavoro è frutto di una miriade di idee, pensieri e descrizioni, di un cospicuo numero di voci che hanno contribuito all’elaborazione del manifesto, a cui l’autore indirizza i suoi ringraziamenti: il comitato scientifico de L’Altramontagna, il giornalista e scrittore Maurizio Dematteis, la fisica dell’atmosfera Sofia Farina, il professore di Sociologia del Territorio all’Università di Pavia Andrea Membretti, Michele Lanzinger, geologo e antropologo, già direttore del Muse di Trento, l’antropologa Irene Borgna, lo storico Matteo Melchiorre e la giornalista Camilla Valletti. Persone che si riconoscono nell’approccio scientifico come chiave di lettura delle grandi questioni ambientali del nostro tempo: “La natura divide anche chi la vuole difendere. In un Paese storicamente poco attratto dalla scienza, pensiamo sia necessario andare controcorrente e promuovere uno sguardo scientifico (scienza come riparo da derive ideologiche), generatore di opportunità per l’ambiente e per la salute individuale.”

E a seguire l’Associazione Riabitare l’Italia, il CAI, iniziative come la Carovana delle Alpi o Carovana dei Ghiacciai e Legambiente. Un merito particolare viene riconosciuto alla Società dei Territorialisti/e che ha curato il Manifesto di Camaldoli (2019) sulla centralità della montagna, che mette come primo punto: “Una montagna frequentata, abitata e produttiva, che presidia il territorio, preserva la piena funzionalità dei servizi, riduce i rischi naturali, salvaguarda il patrimonio, contribuisce all’occupazione e al reddito nazionale, diventa un laboratorio di nuovi stili di vita e di integrazione sociale.”
Queste sono le cime a cui è necessario guardare. Cogliere l’opportunità sta a noi.
 Gabriella Di Lellio
Gabriella Di Lellio