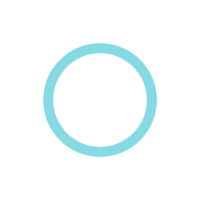Emanuele Severino:
giornalista
Dal terrorismo
allo sbarco sulla Luna
un filosofo
che sapeva divulgare
Una recensione di
FABIO ZANCHI
Il giornalista filosofo racconta il filosofo giornalista. L’uno, Paolo Barbieri, appena abbandonata la professione si è finalmente dedicato all’approfondimento dei propri studi filosofici. Una passione che non l’ha mai abbandonato. Così, è stato tra i fondatori dell’Associazione Emanuele Severino. E di Severino ha puntualmente raccolto, esaminato e riordinato gli scritti comparsi sui quotidiani.
Che ci fosse materia lo dimostra la quantità di interventi: più di cinquecento solo sul 'Corriere della sera', e altri numerosi su 'Bresciaoggi'. Il frutto di tanto lavoro è condensato nelle pagine di “Emanuele Severino giornalista”, edito da Morcelliana nella collana Scholé.
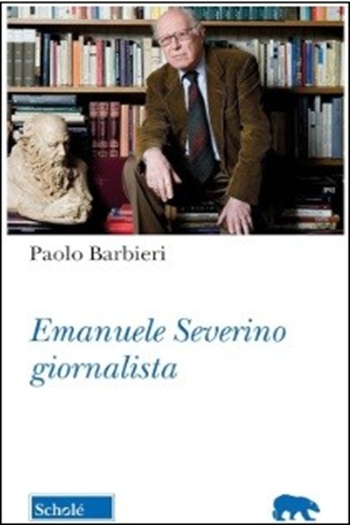
Emanuele Severino giornalista
di Paolo Barbieri
Morcelliana edizioni
19 euro
Erano appena passati quattro giorni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia. Il 1 giugno del 1974 su 'Bresciaoggi' fu pubblicato il commento di Severino, uno dei maggiori pensatori contemporanei. La sua analisi – racconta Barbieri – descrisse esattamente qual era il piano stragista. Solo nel 2015, a distanza di 41 anni, dopo una lunga serie di processi, i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per due ordinovisti, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, spiegheranno sostanzialmente ciò che Severino aveva scritto in quell’articolo: i fascisti di Ordine Nuovo volevano provocare una reazione violenta delle sinistre al fine di giustificare un intervento dell’esercito.
Quell’articolo fu il primo di una serie lunghissima in cui il filosofo si occupò di temi attualissimi come la guerra, il terrorismo, l’aborto e l’eutanasia, la crisi del comunismo, del capitalismo e della Chiesa cattolica, la politica nazionale ed europea. Severino aveva incontrato il giornalismo grazie a Bruno Boni, democristiano, sindaco di Brescia dal 1948 al 1975. Fu lui a proporlo a 'Bresciaoggi', il contraltare laico del Giornale di Brescia, di proprietà della Curia.

Appena cinque anni prima, nel 1969, la Congregazione per la dottrina della fede (l’ex Sant’Uffizio) aveva dichiarato la filosofia di Severino incompatibile con il Cristianesimo. Così il filosofo (“Fu un divorzio consensuale”, disse) abbandonò la cattedra all’Università Cattolica di Milano per spostarsi a Venezia dove fondò il Dipartimento di Filosofia a Ca’ Foscari. I portoni della Cattolica in quegli anni si chiusero alle spalle anche di Mario Capanna, allora leader del Movimento studentesco, che a Severino ha sempre guardato come “il maestro che ci ha indicato le rapide in agguato”, come ha scritto di recente citando Armando Torno.

Che il grande filosofo avesse grande capacità di comunicare in termini accessibili, con un linguaggio accessibile ai non addetti ai lavori, è giudizio molto diffuso e condiviso. La sua capacità di leggere la storia con rigore, abbinata con la scelta di non schierarsi politicamente, è stata la chiave per accostarsi al grosso pubblico dei quotidiani (a quei tempi c’era, eccome: le tirature che oggi sembrano irraggiungibili lo dimostrano). La sua capacità divulgativa è all’origine della decisione di Piero Ottone di chiamarlo al 'Corriere della sera', su proposta di Giulio Nascimbeni, non dimenticabile responsabile della Cultura.
Il 20 luglio del 1979 il suo primo articolo fu dedicato al decimo anniversario dello sbarco sulla luna. Titolo: “Il demone del dominio al di là della luna”, analisi sulla società della tecnica, destinata a prevalere sull’economia e sulla politica. Niente è estraneo all’occhio critico del filosofo impegnato a spiegare ciò che avviene nel mondo. Così interviene sul “bluff” di Kissinger, con la minaccia di ritirare le truppe americane dall’Europa, per indurre gli europei a sposare la politica Usa verso i produttori di petrolio. Il declino dell’economia capitalistica: “È in atto un processo dove è il capitalismo stesso a portare al tramonto se stesso”. Il ruolo di mafia, P2 e Gladio nella lotta anticomunista. Il 18 dicembre 2010 affronta il caso Wikileaks.
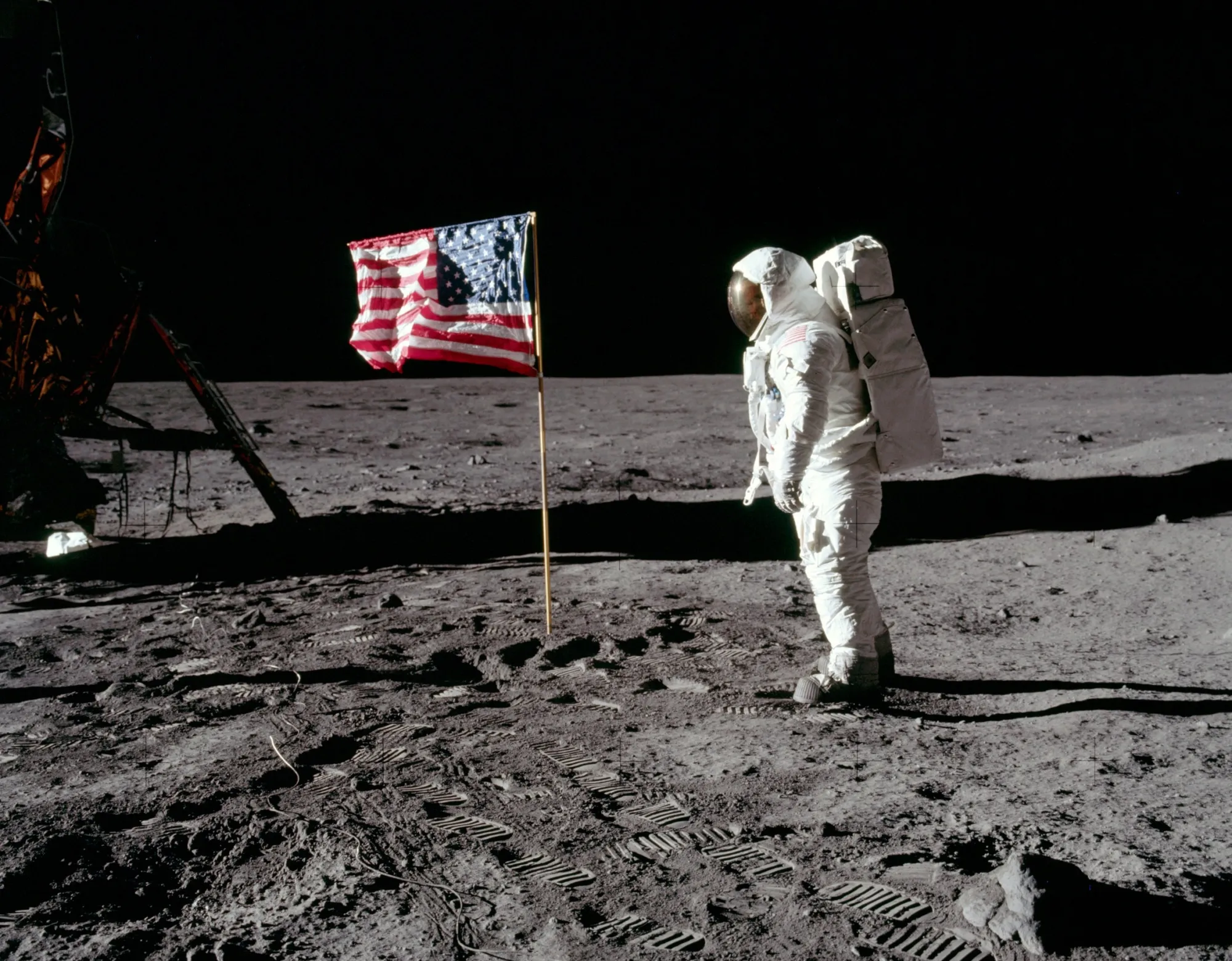
Attentissimo alla cronaca, affronta questioni come i rapporti tra Islam e Cristianesimo, femminismo e femminicidio, l’aborto, l’eutanasia. Polemizza con Moravia e con Pasolini. A quest’ultimo che sul terrorismo aveva scritto “Io so i nomi,” senza rivelarli, Severino contestò questo “silenzio”. Smonta alibi, con semplicità disarmante: “Nonostante i suoi mille volti, il capitalismo ha sempre come obiettivo primario il profitto. Prima o poi la preoccupazione per l’ambiente riduce il profitto. È la sua palla al piede … L’obiettivo finale di ogni forma di capitalismo non è il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, non è il benessere dell’umanità, ma è la crescita infinita del profitto”.
Anche nei confronti del comunismo Severino non usa mezzi termini: “Prigionieri dell’apparenza, non ci si avvide che anche il comunismo era morto ben prima del crollo del muro di Berlino e che anche la sua era una vita apparente”, scrive in un articolo del 21 febbraio del 1999 intitolato: “La fine annunciata del cristianesimo”. Il merito di Barbieri non è solo quello di aver proposto la figura di Severino giornalista, non da tutti conosciuta, ma di averne organizzato la corposa produzione in un modo che ne rende più apprezzabile il pensiero anche a distanza di anni.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI
© Tutti i diritti riservati