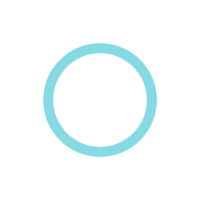Riccardo Frolloni:
"Corpo striato"
Industria e Letteratura editore, 2022
Frolloni è un giovane poeta, cui provo a scrivere una lettera a imitazione di Rilke. Visti i sentieri che percorre e che pure, nel destino che si regala, abbandona. E questo confonde chi legge nel parlarne. Come nelle liriche antiche, nelle prime trascrizioni, si ascoltava il canto aperto e poi il recitativo, l’a parte. Qui il recitativo serve quasi a scusare la lirica, ma pure è nella lirica la parte migliore e desiderante del libro, di cui il poeta sembra volersi scusare e da cui sembra volersi sottrarre.
Il luogo dove canta, sorregge la madre, confessa alla sorella, sogna percorsi con il padre alla guida e gli affanni conseguenti, l’irraggiungibilità del dio/padre.
L’anomalia dei lutti, delle perdite che si devono cantare. E, soprattutto, l’insondabilità dei padri, il mistero delle loro fughe, la sparizione del divino con la scomparsa dell’unico contatto che abbiamo con l’origine.
rispose
quelle poesie
sono terribili, e in una di quelle scrivevo
se papà è stanco/dio è stanco, ma certe cose sono quello che sono
e la poesia
detta un precedente – non avevo dio prima del padre
Così l’urgenza del paese, della montagna nevosa e ruvida, accogliente nel pensiero ma inospitale, fredda e inospitale (ma non nelle foto), di radure sporche e inesplorate.
Sembra questa la misura di tanta poesia di fine Novecento: il padre (la divinità) perduto, la casa degli avi, la minorità straniante della madre nella rinnovata solitudine, il padre che esiste nelle vibrazioni dell’infanzia e nella morte.
La casa era prima di terra e poi d’aria, l’acquedotto
ce lo siamo allacciato noi, con le nostre mani,
la terra infine la nostra e così comincia una stirpe,
seguono vigneti e alberi di prugne, il caco
d’inverno porta frutti rossi su rami secchi,
ancora come una mano afferra i ricordi di casa
col tempo sono stati piantati ulivi, strappati i filari.
Il Friuli di Pasolini, ripreso da Benedetti, (che diremmo essere ispiratore principale di questi versi, non fosse che non ne conosciamo l’eventuale frequentazione) e poi da Cappello. Tutto spostato tra la collina e la montagna maceratese. Con in meno un dialetto senza presunzioni di lingua, agreste, da innalzare o nascondere o depurare. Perché la perdita, nelle parole del terzo millennio, non sia lasciata all’impotenza di una lingua insufficiente, si fa ricorso ai poeti.
I primi a soccorrermi furono i poeti, mentre corro o volo
come in tanti sogni faccio salti lunghissimi e posso con niente
raggiungerti,
io posso
Posso raggiungerti, posso guarire, posso guardare in alto e indietro. Posso rifarti in un calco, in un’imitazione del dio dei ritorni, del dio delle mani e delle impronte, dei risvolti genetici, delle somiglianze e delle distanze.
ora le mie mani sono impronta delle sue, le cerco nei sogni
le sento ogni volta che le richiamo, quelle bianche non erano
più quelle di forza e coraggio, scelgo così di accarezzargli i capelli
cortissimi, come voleva fossero i miei, ma c’era troppo bene poi
Così, in parole che appaiono semplici e di commiato, Frolloni trova l’essenza di questo rigurgito di infanzia, della pace dopo le turbolenze viste o immaginate nel percorso paterno. Col filtro dell’età, con l’onniscienza di chi crede nella perfezione dei destini poveri, nella permanenza del seme, della parola cantata, dell’invocazione, della preghiera. Così scopre l’errore dello sguardo rivolto all’indietro, lo smarrimento e la richiesta.
Padre, tu che ora sei infinito
hai chiuso col passato, noi
invece ti cerchiamo nei frammenti,
nella ripetizione di parole, e sempre
sembri una poesia. Padre, dammi la forza,
fuori c’è un vento un vento un vento
strabico, come i pensieri
Occorre reindirizzare e raddrizzare lo sguardo, dissolversi nel magma dei poeti e dei padri morti. Farsi carico dell’infanzia e del Novecento, pure se si è agli inizi del percorso che porta distanti da ogni padre, dispersi e disperati, all’inessenza.
Frolloni ha gli istinti per farlo, evitando, a nostro modestissimo avviso, di dedicare pagine a lunghi testi di giustificazione all’ardire lirico. Che è questo il verso migliore dei versi che prendono tutta la prima parte del libro. Pure senza il timore di sembrare qualcuno, al padre o al dio del canto.
Però arriveranno, come auspicio, nuove parole, suoni, nenie, senza dediche e malanni dell’animo, senza consolazioni. Coi versi veloci della verosimiglianza, scalzi e dispersi nel mondo. Numinosi ed anonimi, come dovrebbe essere il destino dei poeti.
io per questo di notte cammino scalzo,
farmi parte di questo niente, per paura
che ti possa sembrare qualcuno.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI