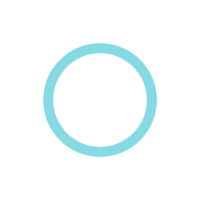Mario Benedetti:
"Tutte le poesie"
Garzanti, 2021
“E’ l’apoteosi dell’impaccio linguistico, è un disarmo unilaterale, è un fare appello alla tenerezza di fronte alla precarietà umana.
È come se l’errore testimoniasse di una più stretta aderenza a quella vulnerabilità che ci accomuna e ci fa deboli al destino.”
(S. Dal Bianco, dall’introduzione al libro)
Non c’è un errore, c’è un’urgenza. Devi andare da qualche parte, devi fuggire da qualcosa e come negli incubi cammini contromano tra la folla delle parole: qualcuna la urti, qualcuna la fai ruotare. La lingua è come il viandante in un ingorgo. Spinge, scansa, fa ruotare, urta.
Il cielo sta nel pensiero di piangere.
Sulla strada
gli uomini sono andati metà muro metà fiume.
Sto qui molto lontano dai templi,
dalle processioni tra i lumini,
molto lontano dai romanzi
dove c’era la luce dei visi.
Tutto col pensiero costante della morte. Del paese, di chi nel paese e nella morte ha forgiato il destino di Mario Benedetti.
È stato un grande sogno vivere
e vero sempre, doloroso e di gioia.
Sono venuti per il nostro riso,
per il pianto contro il tavolo e contro il lavoro nel campo.
Sono venuti per guardarci, ecco la meraviglia:
quello è un uomo, quelli sono tutti degli uomini.
Il banale del volto diventa meraviglia. Ci sono gli uomini, la parola, il paesaggio friulano, i genitori di sangue e ossa. Il sogno del sogno di vivere.
Ho conosciuto Mario Benedetti nella seconda metà degli anni ’80. Ci siamo scambiati versi e riviste. Sentivo quel furore silenzioso
e ancora la malattia non predominava, ancora si cercava il verso, il suono. Mi invitarono una sera ad una lettura in un caffè padovano,
lui, Dal Bianco e Marchiori. Mi ricordo il contrasto evidente tra i vaticini di un aspirante cantore napoletano e l’asprezza del friulano
che provava un mondo. Mi ricordo la sensazione di fallimento.
Poi c’è stata la solitudine per tutti.
Che cos’è la solitudine.
Ho portato con me delle vecchie cose per guardare gli alberi:
un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota.
Ho freddo, ma come se non fossi io.
Poi c’è stata la terra, certo. Campanotto, la poesia italiana in dialetto. Il Friuli fuorviante per tanti.
Guardo, vicino l’acqua, l’acqua.
Quando dici “erba” piango,
quando nelle tue parole ci siamo noi e c’è tutto
l’avere incominciato da piccoli,
qui in questa terra, dici, questa nostra terra.
Fuorviante perché sembrava assolvere, fermare nel tempo ogni espressione. Invece quelle parole, tante parole, non ci sono più. E s’è perduto il senso ma si cammina ancora, una strada affollata per il viandante, un dolore scansare, far finta di non vedere che “non c’è nulla”.
Quante parole non ci sono più.
Il preciso mangiare non è la minestra.
Il mare non è l’acqua dello stare qui.
Un aiuto chiederlo è troppo.
Morire e non c’è nulla vivere e non c’è nulla, mi toglie le parole.
(…)
E io dico, accorgetevi, non abbiate solo vent’anni,
e una vita così come sempre da farmi solo del male.
Perché bisognava esserci in quegli anni. L’onnipotenza e la delusione. Il pensiero di scrivere scolpendo “prigioni”, il pensiero di scrivere cambiando il mondo o, almeno, sconfiggere la vita dolorosissima, la malattia, la morte. E solo il silenzio a rispondere, altri “prigionieri”, altre separazioni, altri urti nel cammino della lingua che si involve.
Ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia,
io nella mia vita non ho letto nessuna poesia.
E questa nessuno l’ha scritta, nessuno l’ha letta.
Così nasce il sosia, l’eteronimo, il veggente che traduce la vergogna di sapere il finale e non avere la forza di svelarlo.
Il sosia guarda, la vita ha deciso.
Vede gli ultimi giorni, si vergogna di scriverlo.
Mario Benedetti è morto due anni fa. Troppo presto per tutti. Era già andato via qualche anno prima. Il dolore e la malattia lo hanno accompagnato a lungo ma la sua poesia dice altro. Dice di un amore potentissimo, di una lingua provata e straordinaria, della fortuna di aver opposto a quel rifugio montano l’inutile grecità del canto in poche serate padovane, in un probabile scarto minimo della visione. A cavallo tra secolo breve e nuovo millennio pochi hanno alzato una voce così dolorosa e potente. La sua tra le più belle.
Dedica
Allora, il tempo della vita dopo. Allora.
Eri lì o una di queste sere. Ma ci vuole affetto
per parlare, dell’affetto per scrivere.
Cose fuori pagina, che si vivono e basta.
Pensieri. E comunque, stai bene? Hai
Studiato, Come passano gli anni,
vedi, come passano gli anni,
e i tuoi sono ancora pochi. E il volere
che non si parli più, non si scriva più
per andare a capo. Una sola voce lontana…
quando sarò non presente a me…
Solo offuscati… e piano piano andarcene.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI