.
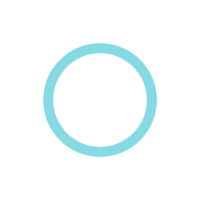
 e
e
di
ANDREA ALOI
Una dolorosa esplorazione nella solitudine di una giovane donna culturalmente “ibrida” perché divisa tra le radici familiari africane e il miraggio francese, tra le tenerezze di una maternità chissà quanto desiderata e le difficoltà di essere accettata come figlia che rifiuta una vita per procura: troppo lontana dalle tradizioni per la dura genitrice, troppo indipendente nelle sue scelte universitarie per il padre. Il commovente, potente “Saint Omer” della franco-senegalese Alice Diop è un film che brulica di emozioni e porta alle lacrime o all’indignazione pur con una messinscena assolutamente povera e riprese nella maggior parte a camera fissa.
Siamo nel tribunale di una piccola città francese dell’estremo nord, va a processo Laurence Coly, schiacciata da un crimine ripugnante, l’infanticidio. Partita da Parigi con Lili, la figlia di quindici mesi, ha trascorso con lei il pomeriggio, le ha dato del cibo, l’ha allattata e a sera l’ha abbandonata sulla spiaggia di Saint Omer, nel Pas-de-Calais, col preciso intento di lasciarla morire affogata dall’alta marea. A domanda della giudice risponde: “Perché l’ho fatto? Pensavo che dopo sarebbe stato tutto più facile”. Normale indignarsi, forse facile prima di aver ascoltato la sua storia per intero. Alle udienze assiste Rama, autrice di libri di successo, è lì per scriverne un altro sul terribile fatto di cronaca, peraltro veramente accaduto nel 2016. Ha già in mente un titolo bruttino, “Medea naufragata”, poco gradito, ovviamente, dal suo editor.
Unite dalla stessa origine senegalese, Laurence (Guslagie Malanga, gioca in sottrazione; quando esplode, commuove) e Rama (la dolce Kayije Kagame) non potrebbero essere più lontane, ma ci sono fili d’acciaio che le legano. Rama ha un compagno affettuoso, il musicista Adrian (Thomas de Porquery), classica bella persona, a suo pieno agio con la sorella e la madre di lei, un’anziana chiusa in se stessa che mai ha metabolizzato lo sradicamento dall’Africa. Laurence ha potuto giovarsi della buona posizione da funzionario del padre, separato dalla moglie, e ha studiato a Parigi, parla un francese impeccabile. Vorrebbe laurearsi in filosofia, facoltà sgradita al padre che avrebbe preferito giurisprudenza e per questo le taglia i mezzi di sussistenza, dal canto suo la madre Odile (Salimata Kamate) l’accusa di essere diventata una parigina.
Laurence soffre tra i due fuochi, è in
difficoltà. E finisce con l’accompagnarsi a un
uomo ben più avanti di lei negli anni, Luc
Dumontet (Xavier Mali). All’esatto opposto di
Adrian, è un classico paraculo, ancora
dipendente in qualche misura dalla ex moglie,
che vede ogni settimana. Laurence: “Vivevo nel
suo atelier, ogni tanto avevamo rapporti, mi
considerava poco. Una volta, ho cucinato per il
compleanno di sua figlia ma non mi lasciato
partecipare alla festa, sono uscita da una porta
sul retro”. Gli studi intanto vengono messi da
parte, si delineano i tratti di una solitudine
che scava, un giorno via l’altro. Quando rimane
incinta Luc le chiede se il figlio è suo. “No, è
solo mio”, risponde Laurence. E saranno mesi di
simbiosi tra figlia e madre autoesclusa dal
mondo. Al punto che l’infanticidio, come in
effetti spesso accade in simili drammi, è anche
un suicidio, un auto-annullamento.

Anche Rama la scrittrice aspetta un bimbo, la tragedia che viene ascoltando in aula la graffia, sente Laurence parlare di malocchio e stregoneria, si spaventa, ha paura di non reggere, di collassare nella mente come sua madre, che certo non le aveva riservato molte attenzioni, viste le grandi difficoltà psicologiche. Non minore effetto le fanno le parole della mamma di Laurence, presente a sua volta alle udienze: “Tu sei incinta, l’ho capito subito”. Madri depositarie di saperi antichi, segni di una cultura non assimiliabile? L’inquietudine monta. Incalzano al processo le domande della giudice (Valérie Dréville), puntuale nelle contestazioni ma attenta, tesa a capire come Laurence è potuta trascolorare dal momento fulgido dell’arrivo di Lilli - “Quando è nata mi è sembrato un privilegio” - all’abbandono mortale. L’infanticida si contraddice, no, non ha lasciato la bambina sulla spiaggia, aveva l’acqua alle ginocchia, è confusa, rompe in un pianto dirotto. Arriva a testimoniare una professoressa di Laurence, concentrato di alterigia bianca e candida stupidità: “Voleva studiare filosofia, le interessava Wittgenstein, ma cosa mai c’entrava con una ragazza come lei?’”. Già, una nera alle prese con un logico austriaco di ardua masticazione: inconcepibile. E cosa c’azzeccano allora i pakistani col cricket? O i cubani col baseball?

Passano sullo schermo immagini della Medea pasoliniana del ‘69 con Maria Callas, uno scarto dall’estetica narrativa, però ben confitto nella storia. Medea è modello archetipico di madre infanticida, uccide i figli avuti con Giasone perché l’ha abbandonata, preferendole Glauce, figlia del re Creonte. Ma c’è tanto altro, che si specchia nel dissesto mentale di Laurence. Medea è maga, non è solo, banalmente, una donna di atavica, barbara indole trascinata dalla gelosia e da una fame insaziabile di vendetta. Vive un conflitto interiore tra la nuova vita in mezzo ai Greci e i riti, gli spiriti della sua Colchide. Giusto come Laurence patisce l’urto tra l’immaginario senegalese e la mentalità d’Occidente.
Nell’arringa difensiva finale l’avvocata Vaudenay (una Aurelia Petit che si fa ricordare) chiama giudice e giurati a considerare l’inutilità di una reclusione, Laurence è folle e va curata: “I geni delle madri passano ai figli e i figli passano i loro geni alle madri, questa è scienza. Una catena infinita tra generazioni. Noi donne siamo chimere, siamo dei mostri terribilmente umani”. Il verdetto rimane sconosciuto. Ritroviamo Rama, - appena prima del sipario sulle note di “Little girl blue” di Nina Simone - a Parigi, tiene per mano la madre. Qualcosa si è benignamente sciolto, la maternità è accettata.

La quarantatreenne Alice Diop è nata in Francia da genitori senegalesi, ha vissuto a nord-est di Parigi, a Aulnay-sous-Bois, “famosa” per il quartiere Cité des 3000, un ghetto abitativo esemplare. Lì ha iniziato a puntare la camera e il suo doc “Vers la tendresse” ha vinto il premio César nel 2017. Con “Saint Omer” ha vinto a Venezia il Gran Premio della Giuria e il Leone del Futuro come migliore opera prima. Il film è uscito da noi in 50 copie, distribuisce Medusa. E, al di là di una estrema asciuttezza sul piano visivo ritenuta da alcuni punitiva, vale invece per quanto lascia dentro. Sono 122 minuti di donne “nuove”, passate da un continente all’altro. Magari ne abbiamo conosciute, le abbiamo sfiorate. Storie di triboli e squarci di luce, vivi e veri come la vita che non ha confini e non si ferma mai.
.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI
© Tutti i diritti riservati