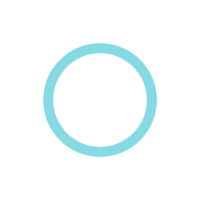Salvatore Palomba:
"Nu cielo piccerillo"
Cuzzolin, 2017
Sono sempre stato distante dalla poesia dialettale. Quella lombarda, romagnola o friulana non la capisco, nel senso che non riesco a leggerla in originale, a cantarmene il suono guardando la traduzione.
Quella napoletana mi genera ancor più diffidenza: temi ripetuti e banali, (la città, l’aria, la nostalgia, il mare, la donna, il paese lontano, i figli), versi forzati, storicamente scritti per la canzone quindi spesso con rime scontate o con una musicalità obbligata.
Poi ho scoperto Salvatore Palomba. In realtà lo avevo scoperto in modo anomalo nel 1987, in circostanze particolari: ero nella sala d’attesa di Villa Betania, stava per nascermi un figlio e per coprire le urla delle partorienti, diffondevano la Carmela di Sergio Bruni. All’epoca per me era di Sergio Bruni, poi ho scoperto che era anche, (e soprattutto), di Salvatore Palomba. Ed ho scoperto Salvatore Palomba e mi sono innamorato della sua Carmela. Più che il vicolo nero, il basso, la ragazza senza speranza, mi colpì, e ancora mi emoziona, la raffigurazione immobile di questa ragazza eterna:
Ma tu stai llà, tu rosa, preta e stella
Rosa, pietra e stella. Fossi stato l’editore, così avrei intitolato questa antologia che parte dagli inquieti versi giovanili, per arrivare a quelli della vecchiaia, arresi e illuminati. Lungo un percorso di poesie in gran parte diventate poi canzoni grazie ad artisti come Sergio Bruni (ma anche agli Almamegretta hanno fatto una bella versione bass & drums di Pe dint’ ‘e viche addò nun trase ‘o mare).
Palomba porta una pietra una rosa e una stella un po’ in tutta la sua scrittura, specialmente dove produce versi non commissionati, (ha una ricca produzione di testi per vari festival e festività napoletane), e in questi elementi fissi della sua iconografia minima, aggiunge un compianto sulla perdita d’innocenza del poeta, che canta per fare il sogno della vita:
Cantammo pe ce sunnà ‘e campà.
Si ‘a vita è suonno c’avimm’ ‘a fa’
E poi ancora, più avanti, diventa maggiore il disincanto:
‘E parole nun servono a niente…
Ce vulesse pe nuie n’ata terra,
terra senza cunfine,
Senza tiempo, senza gente.
Il pensiero del “senza” cerca consolazione in una divinità presente nelle cose, fisica e ripetuta:
Io stevo ccà,
forse io già stevo ccà mill’anne fa.
Ero ‘o scoglio?
Ero ll’onna?
Ero ‘a rena?
Non un vivente reincarnato ma una cosa, immutabile e rassicurante rappresentazione del divino. E alla fine la divinità giunge e consola, nella poesia, a mio avviso, più bella della storia poetica di Palomba e tra le più belle della scrittura degli ultimi decenni, oltre che bellissima canzone ancora una volta musicata ed interpretata da Sergio Bruni:
Che miracolo stammatina
io, cull’uocchie d’’a meraviglia,
veco ‘o munno p’ ‘a primma vota,
comme fosse nù piccerillo
Arrivano gli occhi del fanciullo e permettono al poeta di essere finalmente tutt’uno col mondo delle cose e della natura, di partecipare per un attimo a quel miracolo:
Faccio parte pur’io d’‘o munno,
comme ll’albero e comme ‘a fronna,
comme ‘a nuvola e comme ll’aria,
comme ‘a preta che sta int’ ‘o sciummo
che miracolo stammatina.
Ma il miracolo dura lo spazio di un mattino, non è e non può essere per sempre. Le parole non rendono, non soddisfano. Il percorso personale dalla povertà al benessere, da un quartiere natale periferico ai quartieri alti della città, dalla voglia di riscatto popolare alla resa, non dona l’idea della crescita ma solo la constatazione delle occasioni perdute.
Così il libro si chiude con una disillusa, (volontaria?) citazione da Keats:
E doppo ‘a puisia vene ‘o silenzio.
Bellezza e verità l’aggio tuccate
ma po’ me so’ sfuiute ‘a dint’ ‘e mmane.
Bellezza, verità e, infine, silenzio.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI