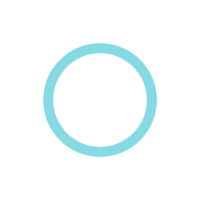La resistenza, per la mia generazione di aquilani che andava a scuola negli anni Sessanta, era una guerra del nord, e Pertini che la raccontava al cinema Rex il 25 aprile. Nell’assenza quasi totale di memoria pubblica della resistenza locale in una città dominata dalla Democrazia Cristiana, i nove martiri aquilani, ai quali era dedicata una piazzetta del centro, erano un’anomalia. Catturati dai Tedeschi, quei nove giovanissimi ragazzi che si erano dati alla macchia furono fucilati il 23 settembre del 1943. Commemorati ufficialmente come autentici partigiani, appunto “martiri”, il pensiero comune locale li ricordava invece più spesso come vittime della loro naïveté giovanile.
A L’Aquila, come dappertutto in Italia, la resistenza ha prodotto “memorie divise”, per dirla con le parole dello storico Giovanni Contini, soprattutto quando si è intrecciata alla storia di stragi. Lo storico aquilano Walter Cavalieri, già autore di L’Aquila in guerra (Gruppo Tipografico Editoriale 1997), ha lavorato su documenti di archivio per smontare le memorie divise dei nove martiri ed ottenere una versione della loro storia il più possibile vicina alla realtà. Tra poco uscirà per la casa editrice Portofranco il suo libro "Processo ai nove martiri", dopo il quale, dice l’autore, "non ci sara più spazio all’immaginazione su questo evento traumatico".

Come fai ad essere così sicuro di aver ottenuto la “verità storica?
"Altri studi si sono già avvicinati alla realtà: quei nove giovani stavano scappando, con un gruppo più largo, per evitare di essere arruolati o mandati ai lavori forzati dagli occupanti tedeschi; un’azione apprezzabile, ma non orientata alla lotta partigiana. Nel 1946 si aprì una fase istruttoria sulla loro fucilazione a partire da un’accusa di delazione. L’istruttoria, conclusasi il 3 ottobre del 1952 con una sentenza a non luogo a procedere, ha lasciato una ricca documentazione".
"Ci sono le deposizioni di tutti i protagonisti, dal memoriale accusatorio della mamma di uno di loro, ai compagni sopravvissuti, i fascisti, l’ex-prefetto badogliano e perfino l’arcivescovo Carlo Confalonieri. Su queste carte ho montato una narrazione, quasi una 'spy story', che ricostruisce ora per ora la storia di quei giovani. Posso pubblicarla solo ora perché quest’anno scadono i settant’anni della secretazione degli atti giudiziari".
E cosa hai scoperto?
"C’è una storia breve, fondamentalmente nota. Erano tutti ragazzi tra i 18 e i 23 anni, una cinquantina, alcuni armati, partiti la mattina del 22 settembre. Verso l’alba, a Collebrincioni (collina a 7 km da L’Aquila), incapparono in un rastrellamento tedesco che cercava militari anglo-americani. Qualcuno fuggì, qualcuno sparò, ma non ci fu un vero e proprio scontro. I più furono portati al Grand Hotel e brevemente detenuti. Nove furono trovati con le armi in mano, condannati, costretti a scavarsi la fossa nel punto delle Casermette più lontano dalla strada e fucilati lo stesso giorno".
"La sentenza di morte era obbligata, secondo il bando di Kesserling contro la resistenza armata. Ma la fucilazione fu tenuta nascosta. Erano i primi giorni dell’occupazione, e ai Tedeschi non conveniva inimicarsi la popolazione. Si fece girare la voce che erano partiti. Solo nel giugno del 1944, quando i Tedeschi andarono via, le famiglie scavarono le fosse e recuperarono i corpi".
"Nel 1945, la piazza cittadina chiamata 28 ottobre in onore della marcia su Roma fu ribattezzata 'Nove Martiri'. Ma la storia non finisce qui. La signora Mancini, madre di Carmine, una delle vittime, depositò uno scritto presso quello che allora era ancora il procuratore del re accusando i fascisti locali di complicità, e uno dei giovani, Aurelio Mascaretti, di aver tradito i compagni. Nel 1946 cominciò l’ istruttoria, ma non si trovò alcuna prova della colpevolezza di Mascaretti o dell’esistenza di una spia".
Allora perché l’accusa della Mancini?
"Anche in altre stragi nazifasciste c’è sempre qualcuno che cerca un capro espiatorio. Poichè è impossibile punire i Tedeschi, se la prendono con quelli più vicini, con responsabili endogeni. Accadde lo stesso nei paesi dell’aquilano Onna o Filetto.
Ho letto proprio nel tuo libro che ad Onna un contadino si ribellò al Tedesco che voleva rubargli la cavalla, lo ferì nella colluttazione e poi scappò. La rappresaglia, partita subito, fece come prime vittime la mamma e la fidanzata del contadino, che non vollero o non poterono rivelare dove si trovava, poi tutti gli uomini del paese, 17 in totale. Per decenni la lapide che in paese ricordava l’eccidio portò esclusivamente i nomi degli uomini, e solo nell’82 furono aggiunti quelli delle due donne, come se fossero colpevoli loro dell’eccidio.
"E quel contadino non tornò mai più in paese. Non poté mai tornare neanche quello che a Filetto ebbe uno scontro a fuoco con un Tedesco perché voleva la sua macchina da scrivere. Anche lì la rappresaglia fece 17 vittime".

"Aurelio Mascaretti non era come il figlio della Mancini, Carmine, uno studente liceale con poca esperienza di vita. All’epoca contro di lui c’era in corso un altro processo per furto. Mascaretti testimonió nella fase istruttoria e si disse molto indignato delle accuse. Anche lui era armato quella notte, ma era riuscito a liberarsi delle armi in tempo e quindi era capitato nel gruppo dei non condannabili. Si era poi unito al gruppo partigiano della De Vincenzo, quindi nel dopoguerra era membro dell’ANPI. Ci sono testimonianze che confermano o smentiscono un suo possibile tradimento, inclusa l’accusa che avesse conosciuto il bando tedesco prima che fosse pubblicato, ma nessuna prova".
Seguendo Alessandro Portelli, che sviscera questioni simili nel suo bellissimo libro su via Rasella, L’Ordine è già stato eseguito, direi che la signora Mancini scrive come una mamma addolorata, ma quello che scrive va messo nel contesto del dopoguerra e del sentimento anti-partigiano che molta gente, specialmente non comunista e anti-comunista, aveva, e soprattutto a L’Aquila, città di destra. Chi era la signora Mancini?
"Era un’insegnante, ma lavorava al Provveditorato. Certamente era una donna istruita che apparteneva ad una classe più elevata delle altre madri. Ma non sembra rancorosa nei confronti dei partigiani, anche se l’ANPI difese Mascaretti. Anzi, cercò di coinvolgere i fascisti locali. Secondo me era solo una madre che cercava di dare un senso all’uccisione del figlio".
Insomma, non ci sarebbe stata alcuna spiata. Però a L’Aquila si continua a parlarne. Laura Benedetti, aquilana e Chair del dipartimento di Italiano a Georgetown, mi ricorda un personaggio del suo bel romanzo Un paese di carta, pubblicato nel 2016: la sorella del più giovane dei martiri, esule dalla città e dall’Italia a causa della delazione che uccise il fratello. Personaggio storico? "No, è completamente inventato – dice Laura – tanto che ho letto solo due testi sull’evento e non ho fatto altre ricerche proprio per dare più margine alla mia immaginazione. Pensa alla mia sorpresa quanto nel 2018 mi capitò un video di Pina Alleva, la sorella di Anteo, uno dei martiri, che ripeteva la versione della delazione. Il personaggio del romanzo esisteva davvero!"

Mentre attendo con ansia di leggere il libro di Cavalieri, non sono convinta di essere certa, come lo è lui, che un’accurata ricostruzione storica possa mettere punto alla discussione sui nove martiri aquilani. Come dice Portelli, un evento traumatico comincia a generare storie nel momento stesso in cui avviene, e quelle storie non finiscono mai. Spesso non sono accurate come vorrebbe la storia con la maiuscola, ma sono piene di significati.
La versione della ragazzata andata a male, così diffusa nei decenni, assolve una società locale in parte complice ma in maggior parte passiva rispetto ai nazifascisti per i motivi più diversi. Si pensi all’arcivescovo, che sapeva della fucilazione ma tenne nascosta la notizia. La storia della delazione individualizza la responsabilità collettiva e se la prende con chi riesce a scampare all’eccidio, un ragazzo non appartenente alla società perbene, e per giunta partigiano in una città che dette la vittoria alla monarchia nel referendum del 1946. La versione dell’eroismo partigiano assolve probabilmente quei militari locali che avrebbero dovuto guidare i ragazzi ma non lo fecero, chissà perché. Il mio sospetto è che il libro di Cavalieri non metterà alcun punto alla discussione, ma creerà nuove storie.