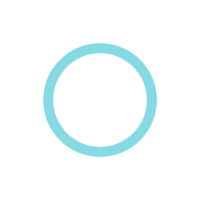
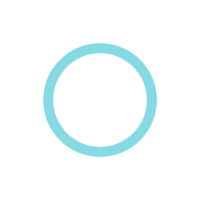

Nell’altopiano di Navelli, lungo le strade percorse per secoli da monaci, pellegrini e pastori, nel borgo di Bominaco si trova quel che resta di un antico complesso benedettino: la chiesa di Santa Maria Assunta e l’Oratorio di San Pellegrino, la "Cappella Sistina d’Abruzzo", così l’ha definita Vittorio Sgarbi, che è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità nel 1996.
L'espansione benedettina in queste zone risale all’epoca longobarda, con le prime grandi fondazioni del settimo e ottavo secolo, per proseguire in età carolingia. Bominaco, a metà strada tra L’Aquila e Sulmona - una frazione di Caporciano – conta poco meno di cento persone. Il nome antico era Mommenaco, poi Mammata fino all’attuale denominazione, apparsa nel 1223 nei documenti pontifici di Onorio III. Il monte Buscito, su cui è poggiato, ha sulla vetta un castello antico di cui resta una torre alta e massiccia con le mura di cinta.
Poco fuori paese, su una collina coperta di pini giovani, c’è la chiesa di Santa Maria Assunta. Più in basso, a formare un angolo retto, la più piccola di San Pellegrino, detta l’Oratorio. Entrambe facevano parte di un monastero dell'inizio dell'era cristiana. Tra il III e IV secolo qui fu martirizzato e sepolto San Pellegrino, di provenienza siriana. Alcuni secoli dopo, sulla sua tomba, venne edificata la prima chiesa donata all'abbazia benedettina di Farfa, da cui Bominaco si rese indipendente nel 1001.
La posizione strategica, nei pressi del tratturo ma anche vicina alla via per L’Aquila, è attestata dal fatto che gli abati riscuotevano il diritto di passo sul transito delle greggi nel proprio territorio. Dopo la distruzione nel 1423 da parte di Fortebraccio da Montone, la vita monastica si estinse. L’abbazia fu soppressa a metà del ‘700 e trasformata in semplice parrocchia sotto la giurisdizione del vescovo dell’Aquila. Nel 1902 il complesso fu dichiarato monumento nazionale. Oggi ne restano solo la chiesa e l’Oratorio, due esempi dell’architettura romanica abruzzese.
La struttura medievale venne recuperata, insieme ad alcuni arredi liturgici, nei lavori di restauro dal 1930 al 1960, supervisionati in ogni fase da Antonio De Dominicis, conosciuto in paese come don Antonio, della soprintendenza dei beni culturali dell'Aquila. Fu proprio quest’ultimo a consegnare le chiavi delle chiese ad un uomo del posto per far visitare il complesso abbaziale. Un’attività tramandata nel tempo. Nessun appuntamento. È sufficiente recarsi di fronte all’Oratorio di San Pellegrino e contattare il numero indicato sul cancello.

Dell'Oratorio non si conosce con precisione la data di edificazione, di certo precede il 1180 riportato sull’ambone e il 1223 inciso sull'altare. Le prime fonti in cui il monastero viene citato come ecclesia sancti Peregrini è il diploma imperiale di Corrado II del 1027. La chiesa si trova in alto rispetto all’Oratorio e la prima cosa che colpisce è la pulizia estetica della facciata, con una finestra monofora a tutto sesto contornata da quattro leoni e un portale scolpito con un motivo di palmette a pannocchia che fiancheggiano un piccolo leone centrale.
Altri due ingressi si aprono sui lati, ma solo quello di sinistra è decorato. Rappresentava l’uscita dei monaci per raggiungere l’accesso secondario dell’Oratorio di San Pellegrino. Se invece si raggiunge la chiesa dall’Oratorio, si resta colpiti dalla bellezza dei tre absidi che poggiano sulle rocce.
All'interno le tre navate sono separate da dodici colonne tutte disuguali con capitelli diversi tra loro, probabilmente realizzati con materiale recuperato dalla vicina Peltuinum, antica città dei Vestini. Su un lato della navata centrale c’è l’ambone del 1180, ricomposto nel 1934 recuperando le parti smembrate nel corso del ‘700. Poggia su quattro colonne di cui solo una con scanalatura a spirale, le altre sono lisce.
A fianco era posto il candelabro, ora vicino all’altare. Una colonna tortile, chiusa da un capitello a bocciolo con un ornato vegetale. La base poggia su un leone ritto sulle zampe del XII secolo. Nella zona presbiteriale si trova l’altare, con l’unica decorazione dell’agnello crucifero, e il ciborio che lo sovrasta. Sul fondo c’è la cattedra abbaziale che posa su tre gradini affiancati da due leoni ritti sulle zampe di cui oggi rimangono pochi frammenti. Lo schienale termina con una cuspide e i due braccioli sono due lastre di pietra decorate con capitello a foglie di palma. Nella lastra destra è raffigurato l’abate Giovanni con le insegne vescovili. All’interno della chiesa, sulla navata sinistra e sulla controfacciata dell’abside, si riconoscono ancora frammenti di affreschi tre-quattrocenteschi, tutti rinvenuti sotto gli stucchi barocchi eliminati durante i restauri.
Arrivando al cancello del complesso benedettino, percorsa una breve salita, ci si trova di fronte a un semplice portico a tre arcate sorretto da colonne di età romana. La struttura si presenta spoglia di qualsiasi decorazione. Ma l’esterno non deve ingannare, la meraviglia si cela all’interno.
Il primitivo Oratorio di San Pellegrino venne fondato presumibilmente nell’VIII secolo sul luogo ove era sepolto l’omonimo santo di provenienza siriana. Altre fonti indicano la fondazione nel 1263 per volontà dell’abate Teodino. Due iscrizioni confermano la datazione: una sull’architrave del piccolo rosone della facciata posteriore e l’altra sui plutei in pietra all’interno.
Anche in questa chiesa ci sono stati interventi di restauro, nel 1913, per dotare l’edificio di porte, sistemare con urgenza il tetto e la pavimentazione disastrata dalle infiltrazioni. Varcato il portone si rimane abbagliati da un trionfo di affreschi del XIII secolo, in ogni angolo delle pareti e del soffitto, realizzati al tempo stesso della sua edificazione.
L'oratorio è un piccolo ambiente a navata unica privo di abside, lungo 18,70 metri per 5,60 di larghezza, sormontato da una volta a botte ogivale e un campanile sulla facciata posteriore. La volta è divisa in quattro campate da quattro archi di rinforzo. Lungo il suo perimetro si sviluppa una cornice con la funzione di separare le aree affrescate. I dipinti occupano tutto lo spazio dei muri e della volta. Oltre la curvatura della volta stessa, al centro di essa, c’è una fascia dipinta con motivi geometrici e stilizzati.
Gli affreschi sono opera di tre pittori monaci artisti, diretti dallo stesso abate, noti con i nomi di “Maestro della Passione”, “Maestro dell’Infanzia” e “Miniaturista”. È una delle testimonianze più rilevanti della pittura medievale nella regione. Narrano storie dell’infanzia di Cristo, scene della Passione, scene del Giudizio Universale, di San Pellegrino. Altre sono dedicate al Calendario monastico con le personificazioni dei mesi, i segni zodiacali e le fasi lunari.
Il ciclo del Calendario, a differenza degli altri, presenta caratteri innovativi anticipando la pittura gotica dei cicli monumentali dei mesi che si diffusero nell’Italia settentrionale e in Francia nella cattedrale di Notre Dame di Parigi. Sono chiaramente visibili solo i primi sei mesi del Calendario. Gennaio rappresentato da un uomo che beve da una fiaschetta, febbraio da un uomo che taglia i rami di un albero, marzo da un uomo dormiente, aprile da un uomo che tiene in mano due fiori, maggio da un uomo a cavallo e giugno da uno che raccoglie la frutta.
L’interno dell’Oratorio è diviso da due plutei in pietra decorati da un drago, a sinistra, e un grifone, a destra. Servivano a separare gli spazi dedicati ai fedeli da quelli riservati ai catecumeni.
